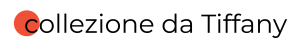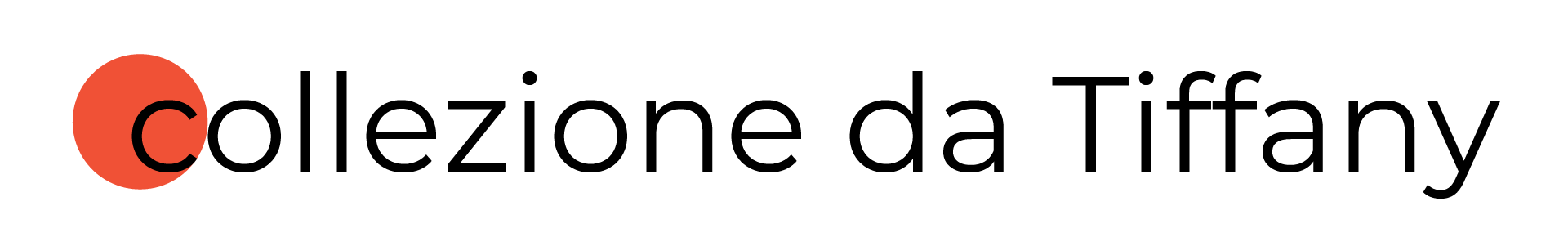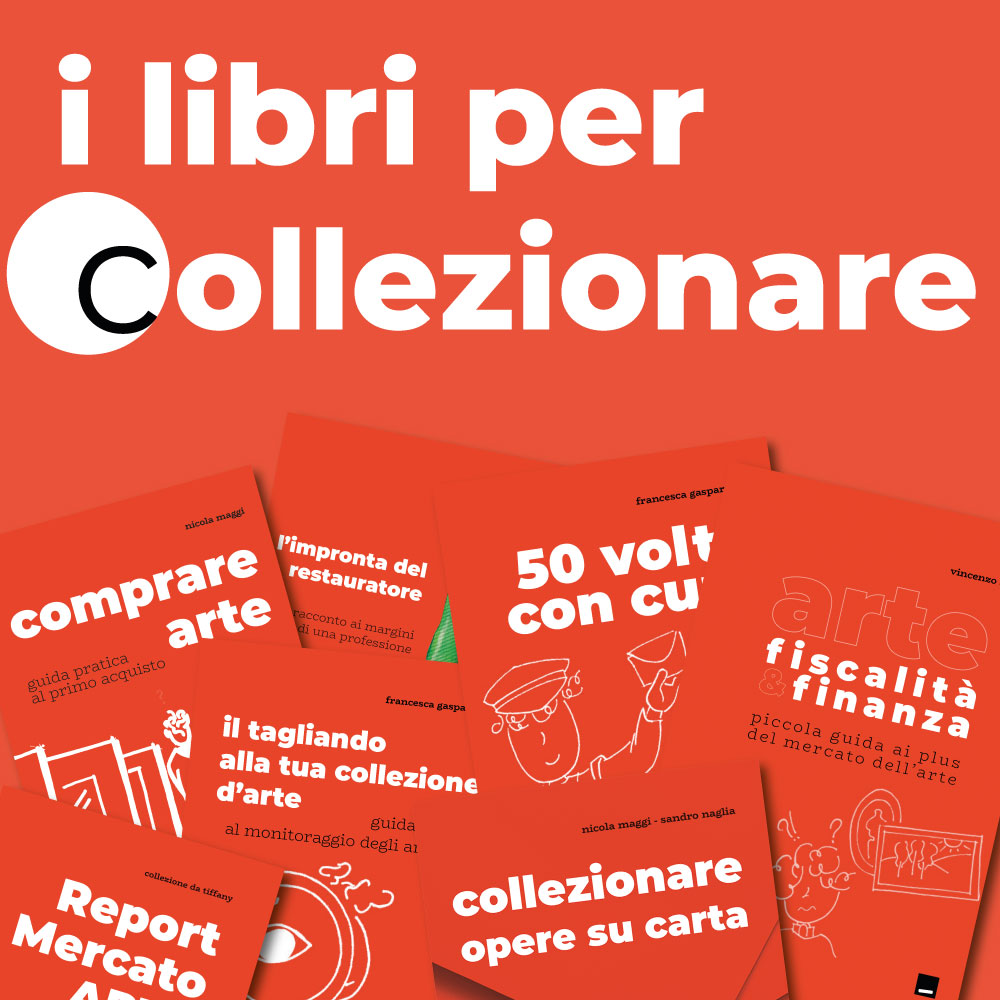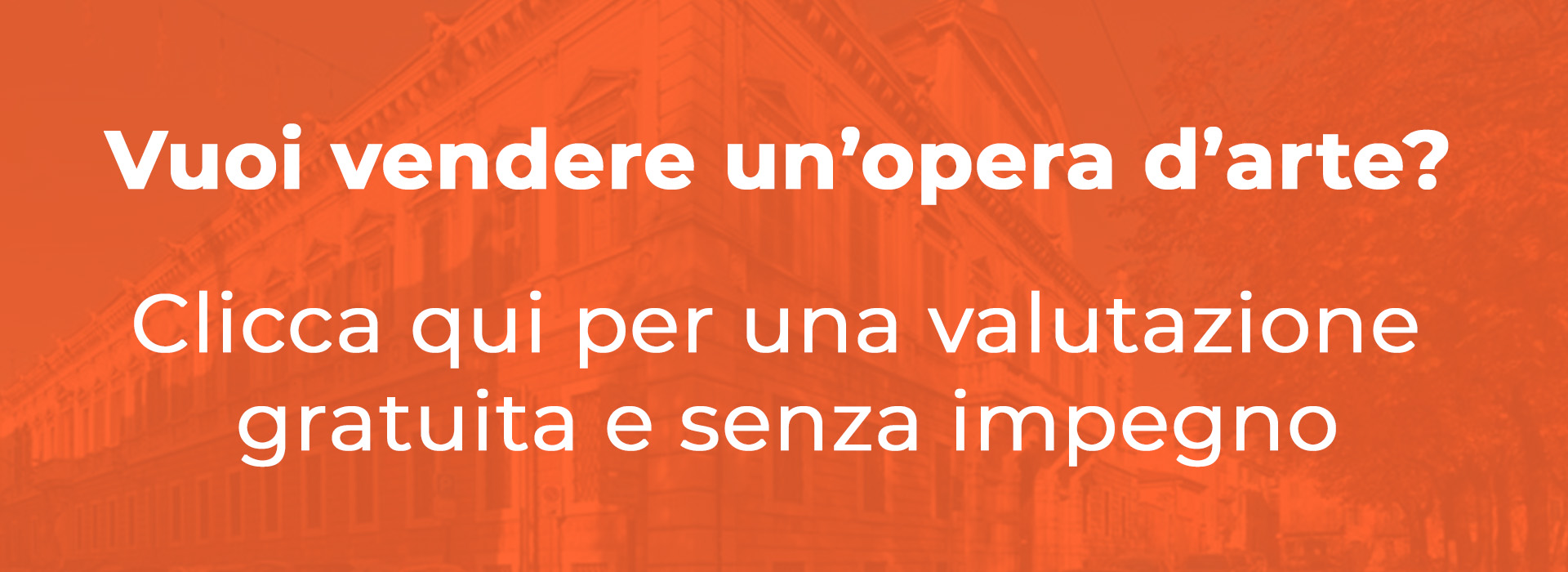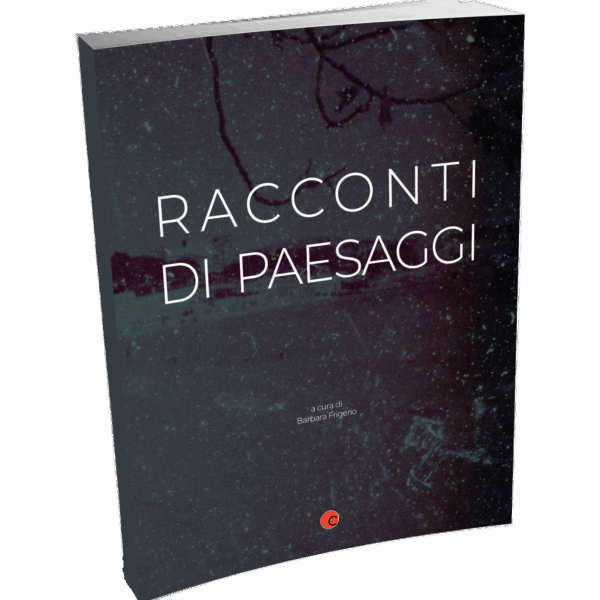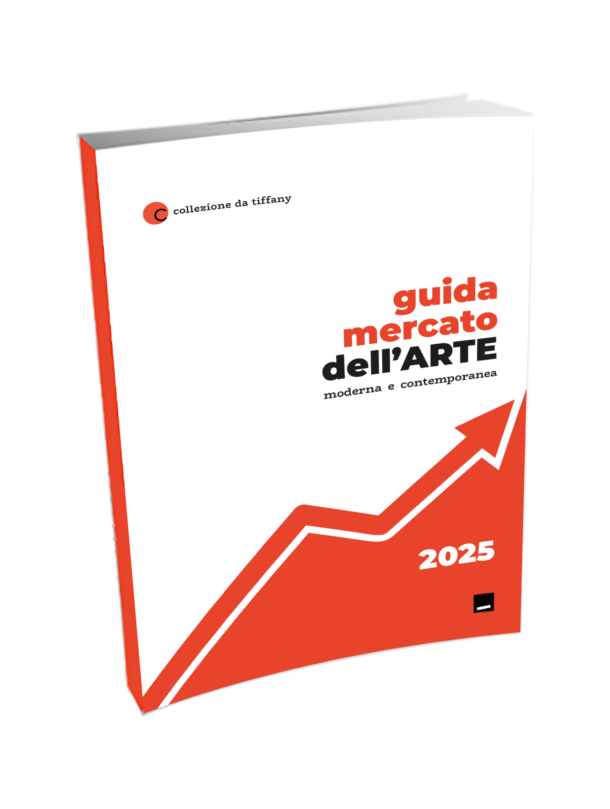La c.d. “prelazione artistica”
Il diritto di prelazione rappresenta uno degli strumenti più significativi di cui dispone lo Stato per la tutela del patrimonio culturale. Introdotto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, successivamente recepito nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e ad oggi disciplinato dagli articoli 60-62 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito, “Codice beni culturali”), il diritto di prelazione consente al Ministero – o, in subordine, alla Regione o da altro ente pubblico territoriale interessato – di acquisire beni culturali alienati a titolo oneroso, subentrando all’acquirente alle medesime condizioni economiche previste nell’atto dispositivo.
Più in particolare, la prelazione artistica consiste in un procedimento amministrativo che prevede l’esercizio di un potere pubblico di acquisire beni vincolati per il perseguimento di finalità di interesse generale, quale la tutela, la conservazione e il pubblico godimento del patrimonio storico-artistico nazionale. La ratio dell’istituto risiede dunque nell’esigenza di garantire un controllo pubblico sugli atti dispositivi posti in essere da soggetti privati (lato sensu), allo scopo di assicurare una più efficace tutela, conservazione e valorizzazione attraverso l’acquisizione del bene al patrimonio statale.
Il procedimento: denuncia e termini e modalità di esercizio della prelazione
Il diritto di prelazione sui beni culturali può essere esercitato dal Ministero, dalla Regione o da altro ente pubblico territoriale interessato, ai sensi degli artt. 60-62 del Codice beni culturali. La norma cardine (art. 60, co. 1, Codice beni culturali) dispone che: “Il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento […]”.
Si tratta di un potere amministrativo che si attiva a seguito della comunicazione (denuncia) di un atto di trasferimento a titolo oneroso, come ad esempio una compravendita o un conferimento in società.
In base all’art. 59 del Codice beni culturali, la denuncia deve essere trasmessa alla Soprintendenza territorialmente competente entro 30 giorni dalla stipula dell’atto; da tale momento decorre il termine di 60 giorni consecutivi entro il quale l’amministrazione può decidere di esercitare la prelazione, notificando – entro tale termine – il relativo provvedimento di acquisizione sia al venditore che all’acquirente, in via di prelazione, allo stesso prezzo indicato nell’atto. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa, presentata tardivamente oppure risulti incompleta, l’art. 61 del Codice beni culturali prevede un termine più ampio, pari a 180 giorni, che decorre dal momento in cui il Ministero ha ricevuto denuncia tardiva o ha acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa, necessari per valutarla.
Condizione sospensiva e natura dell’intervento pubblico
La prelazione si esercita dopo la stipulazione del contratto tra soggetti privati avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene culturale a titolo oneroso, e ne sospende l’efficacia (di tale atto) sino alla scadenza del termine previsto per il suo esercizio da parte del Ministero (60 o 180 giorni, a seconda dei casi). Nelle more di definizione del provvedimento di prelazione, l’atto di alienazione rimane sospensivamente condizionato all’eventuale esercizio della prelazione e all’alienante è vietata la consegna del bene all’acquirente, che deve rimanere in possesso del venditore. L’acquirente acquisterà la proprietà del bene solo dopo i 60 giorni (o 180 giorni, a seconda dei casi), se la prelazione non è stata esercitata; trascorsi i 60 giorni (o 180 giorni), in assenza di notifica, il bene può essere consegnato al nuovo proprietario.
Qualora il Ministero decida di esercitare la prelazione solo su una parte dei beni oggetti del contratto, è fatta salva la facoltà dell’acquirente di recedere dal contratto.
Dunque, la prelazione ha ad oggetto un contratto già precedentemente concluso tra le parti private. È proprio l’atto traslativo tra i privati, debitamente comunicato all’amministrazione, che legittima l’esercizio di tale diritto. Ne segue che lo Stato (o gli enti territoriali interessati) non diviene parte del contratto traslativo, ma interviene con un atto discrezionale ablativo in base all’atto già perfezionato, che comporta l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico agli stessi termini economici previsti nel contratto originario qualora decida di esercitare il proprio diritto.
L’esercizio della prelazione è previsto solo per trasferimenti di proprietà a titolo oneroso (quali, ad esempio, la vendita totale o parziale, la permuta, il conferimento in società, ecc.). In questo caso, lo Stato – o, in subordine, la Regione, la Provincia o il Comune territorialmente interessati – può esercitare, come già detto, la prelazione, subentrando all’acquirente alle medesime condizioni economiche previste nell’atto a titolo oneroso. Al contrario, non è ammesso l’esercizio della prelazione in caso di trasferimenti a titolo gratuito, quali successioni ereditarie, donazioni, divisioni, così come cessioni di partecipazioni societarie, fusioni, scissioni o costituzioni di ipoteca. Tuttavia, anche questi atti sono soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 59 del Codice beni culturali, che impone di trasmettere alla Soprintendenza la notizia dell’atto entro 30 giorni dalla sua stipulazione, pur in assenza del diritto di prelazione.
Conclusioni
La prelazione artistica rappresenta un equilibrio tra libertà contrattuale e interesse pubblico, consentendo allo Stato di esercitare una funzione attiva nella protezione del patrimonio culturale, senza impedire tout court la circolazione dei beni. Attraverso questo strumento, l’amministrazione pubblica può intervenire evitando dispersioni del patrimonio e assicurandone la conservazione e la fruizione collettiva.