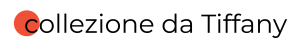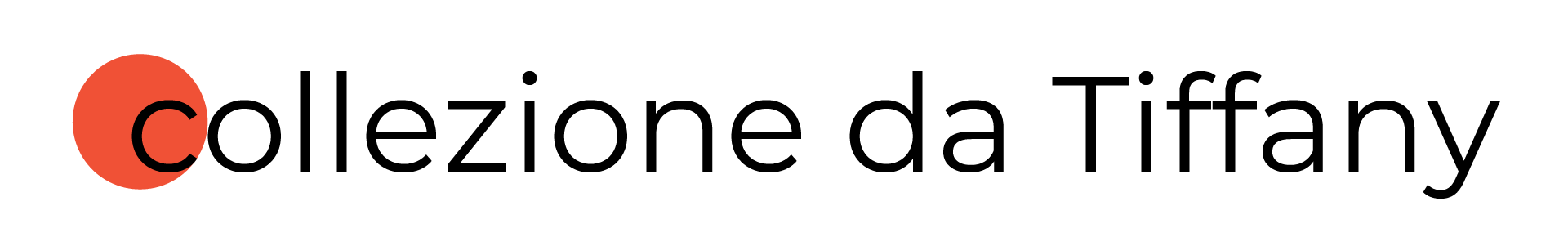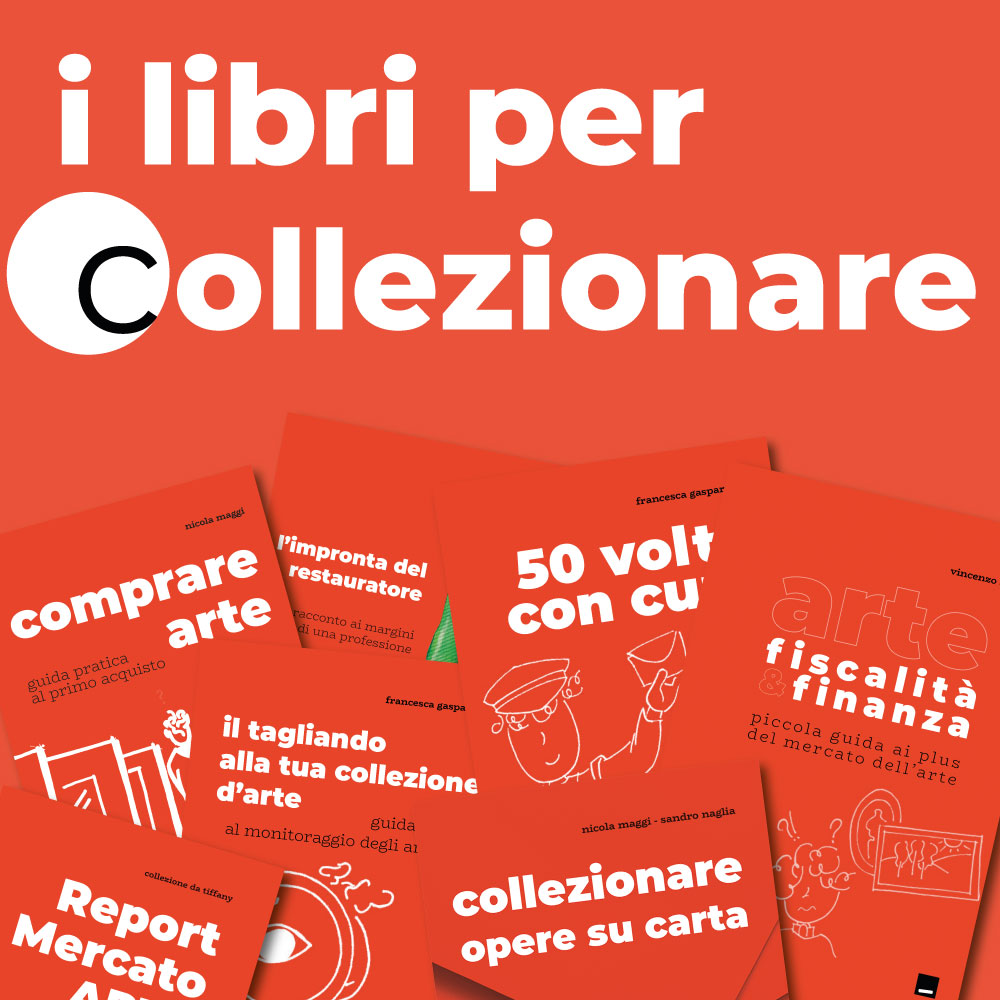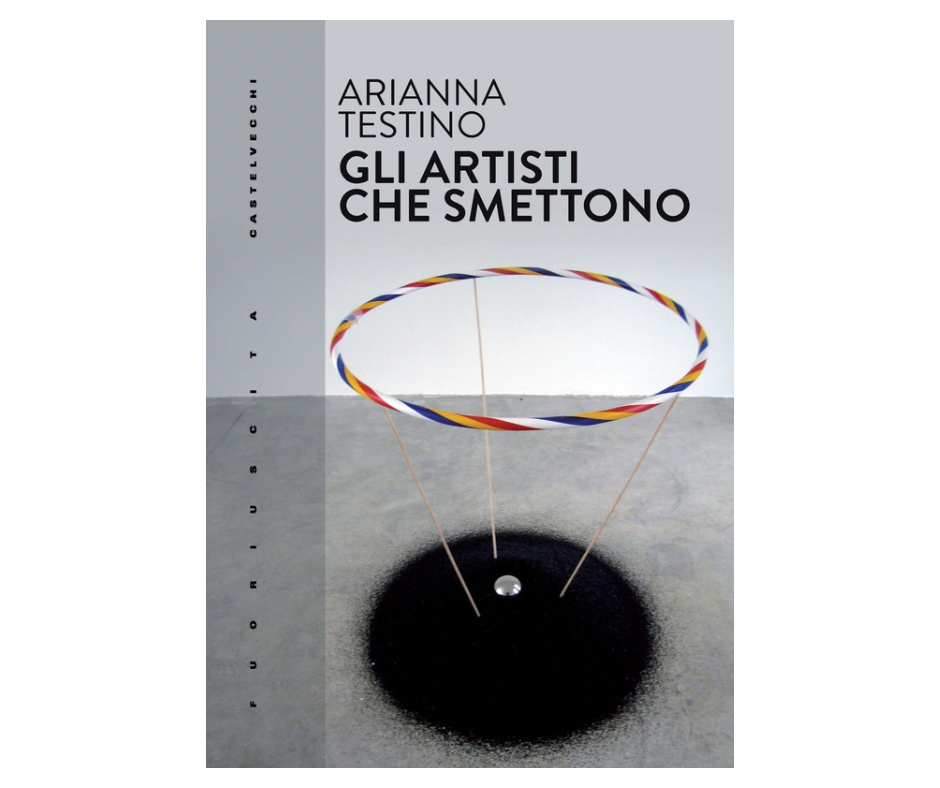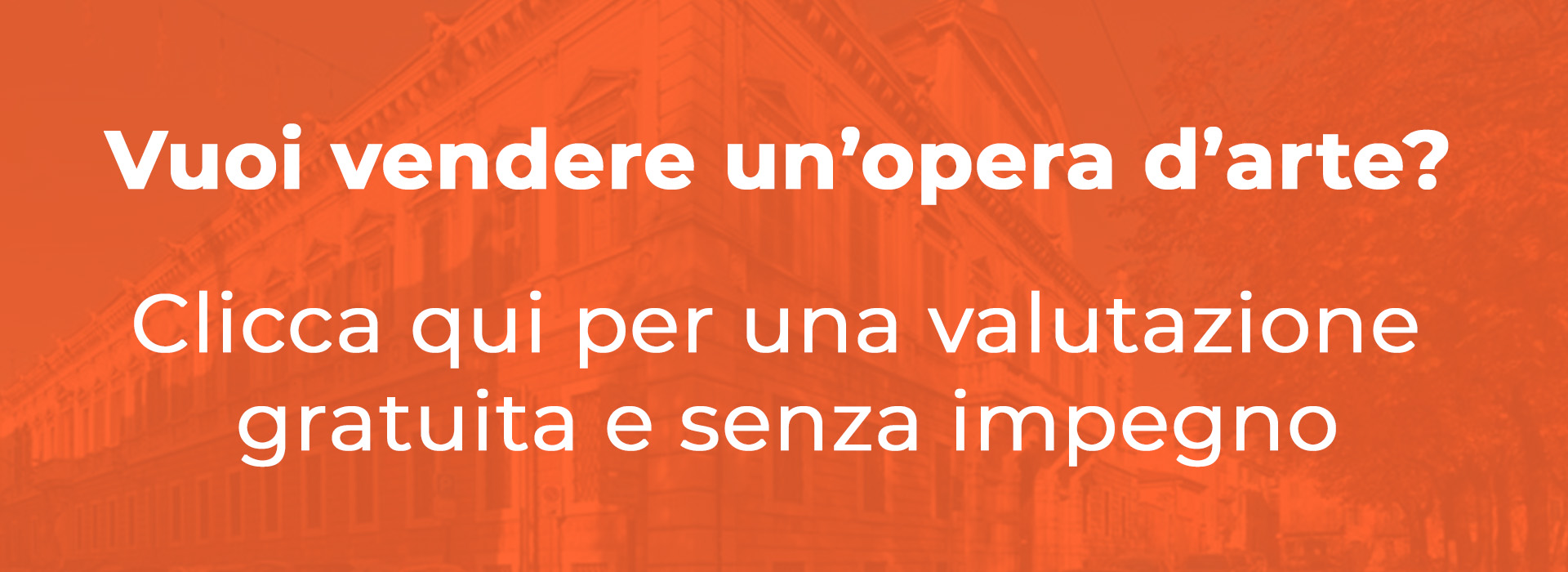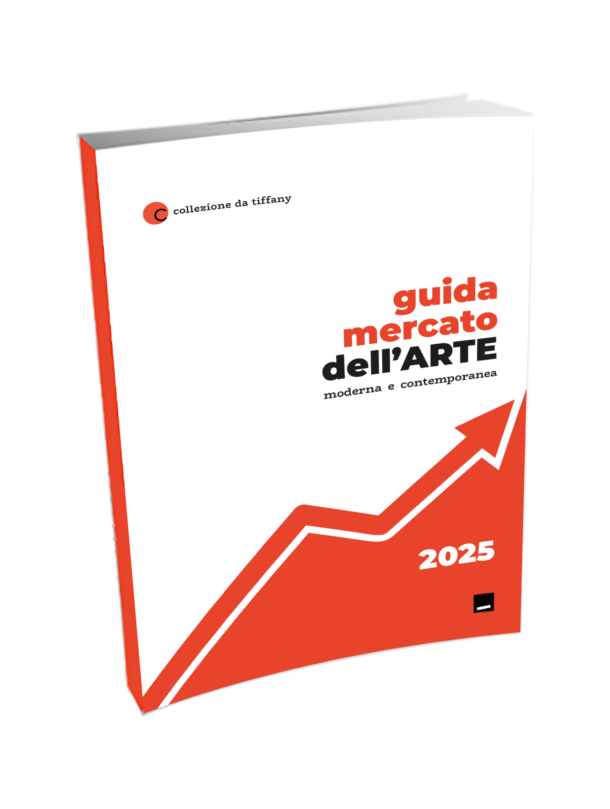(Edizioni Castelvecchi, collana Fuoriuscita)
Che cosa significa, davvero, “smettere di essere artista”? Si può davvero smettere o si tratta di una trasformazione, di una migrazione interiore verso altre forme di espressione e di vita? Arianna Testino, nel suo saggio “Gli artisti che smettono”, affronta questa domanda con una lucidità e una profondità rare, tracciando un percorso che tocca tanto le biografie individuali quanto i grandi movimenti sociali contemporanei.
La problematica, in primis, si incentra sui termini “essere artista” o “fare l’artista”. Come ricorda Parmenide, l’essere finché è, non cambia. Ci verrebbe quindi da pensare che si possa solo cessare di fare arte ma non di essere artisti.
Si tratta comunque di supposizioni arbitrarie e, proprio per superare tali limiti, Arianna Testino ha iniziato la sua ricerca che trova momento di sintesi nel testo editato, ora in commento.
A metà strada tra critica d’arte, saggio filosofico e indagine sociale, il volume analizza le ragioni – intime, psicologiche, sociali e culturali – che hanno spinto diversi artisti, dal Novecento ai giorni nostri, a dire basta, ho finito! Non si tratta solo di una pausa o di un momento di crisi: smettere, in molti casi, è una scelta definitiva, radicale, una forma di resistenza o di ultravivenza ad un sé che evolve oltre i limiti che possono garantire continuità e identità.
Tra i casi emblematici, spiccano figure come Lee Lozano e Christian Frosi che hanno scelto un silenzio assoluto e programmatico, oppure come Jerry Saltz, artista mancato che, dopo un percorso di dolore, fallimenti e autocritica, è divenuto uno dei più influenti critici d’arte al mondo.
Testino racconta con cura la sua parabola: dall’ambizione giovanile di illustrare la Divina Commedia a Chicago, alla conquista del Premio Pulitzer per la critica.
Il libro non si limita alle storie individuali: incrocia queste biografie con fenomeni globali come la Great Resignation, quel movimento di massa post-pandemico in cui milioni di persone hanno deciso di lasciare il proprio lavoro in cerca di ulteriore o diverso senso per la propria vita. Così, l’atto di smettere diventa anche atto politico e culturale, rifiuto consapevole delle logiche di produttività a oltranza o di permanenza nei limiti che abbiamo imposto al nostro io.
Un parallelo interessante che viene in mente, leggendo la Testino, è quello con il celebre compositore Gioachino Rossini che a soli 37 anni – nel pieno del successo dopo il trionfo del “Guglielmo Tell” – decise di abbandonare l’attività di compositore. Le motivazioni di quel ritiro restano ancora oggi avvolte nel mistero: stanchezza creativa, problemi di salute, disillusione nei confronti del sistema teatrale o forse semplice desiderio di vivere per sé stesso, lontano dalle aspettative del pubblico che prima crea l’artista e poi pretende di progettare con lui. Eppure, anche Rossini, pur “smettendo”, non abbandonò del tutto la musica: si dedicò alla composizione di brani più intimi, raccolti nei celebri “Péchés de vieillesse”, quasi a testimoniare che l’identità artistica non si spegne ma cambia forma, attingendo all’universo del silenzioso e del poco evidente.
Testino accompagna il lettore in queste riflessioni sul dropout artistico con stile chiaro, mai accademico, accessibile anche a chi non abbia una formazione specifica in storia dell’arte. Ogni capitolo si apre come una finestra su un caso studio e su un tema portante: controllo, fallimento, arte-vita, sottrazione, fino ad arrivare alla domanda più radicale: può l’abbandono diventare una forma d’arte?
Il saggio diventa così anche una mappa di possibilità per chiunque oggi senta la necessità di “staccarsi” da un ruolo, da un’identità o da una carriera. Non c’è una sola risposta, come dimostrano le traiettorie, diversissime, di Duchamp, Martin, Cattelan e Saltz. Ma c’è una certezza: smettere, in arte come nella vita, può essere una scelta di libertà.
“Gli artisti che smettono” è un libro che piacerà molto per chi si interroga sul senso del fare creativo, sui confini tra identità e professione, e su come sia possibile, a volte, trovare salvezza proprio nel gesto di dire basta, dando un altro sé stesso alla propria esistenza.
G.S.M.: Nel libro lei racconta storie alquanto diverse di artisti che hanno cessato di produrre: da Lee Lozano a Jerry Saltz. Secondo lei, cosa accomuna questi dropout, al di là delle singole motivazioni personali? C’è un fil rouge che lega queste scelte?
Credo che tutti loro – Christian Frosi, Lee Lozano, Agnes Martin, Marcel Duchamp, Maurizio Cattelan, Jerry Saltz –, a più riprese, abbiano messo in discussione il concetto di “fare arte” e, soprattutto, le dinamiche del sistema a cui il “fare arte” deve rispondere. Ognuno di loro, seppur con modalità differenti, ha praticato una rottura nei confronti di questo sistema, sperimentando dropout altrettanto diversi ma accomunati da una reazione – al contempo umana e professionale – a meccanismi implacabili. C’è chi, come Frosi e Lozano, ha scelto una strada senza ritorno, mentre per Martin il dropout ha i contorni di una pausa, i cui effetti, tuttavia, echeggiano in modo perentorio nella decisione dell’artista di tornare all’opera. L’idea di dropout, di perenne sottrazione è insita nella poetica di Cattelan fin dagli esordi e, in un certo senso, anche Duchamp, sfuggendo alle etichette che garantiscono la stabilità del sistema e inscenando una sparizione apparente, scivola leggero sulla superficie di definizioni granitiche e falsamente rassicuranti. Saltz smette di fare arte nel momento in cui stare nel sistema diventa insopportabile. Eppure Saltz non abbandonerà né l’arte né il sistema, ma li affronterà da un’altra prospettiva, quella della scrittura e della critica. Come dicevo all’inizio, ad accomunare tutti loro è l’impulso a mettere e mettersi in discussione e a reagire.
G.S.M.: Il fenomeno delle “Grandi Dimissioni” ha riportato al centro del dibattito pubblico la possibilità di interrompere una carriera apparentemente di successo. Quanto ha influito questo contesto sociale nella decisione di scrivere il libro e nel modo di impostare la sua analisi?
L’idea alla base del libro ha preso forma dopo aver visitato la mostra dedicata dalla GAMeC di Bergamo a Christian Frosi nel 2022, quando il mondo, all’indomani della pandemia, vedeva crescere e consolidarsi il fenomeno delle Grandi dimissioni. Fenomeno che certamente, come scrivo nell’introduzione al saggio, ha reso ancora più attuale l’argomento trattato. Scegliere di interrompere – una carriera, un percorso, gli esiti di una decisione pregressa – è una possibilità che i sei protagonisti del volume – e altri come loro – hanno vestito di sostanza, modellandone l’estensione, i limiti, la durata. Imboccare la strada del dropout è una presa di posizione dettata ancora una volta dalla necessità di rivedere le regole di un gioco al quale non si è più disposti a prendere parte. Il fenomeno delle Grandi dimissioni ha dato finalmente voce, su scala globale, a un’urgenza personale e collettiva che ha radici profonde e che merita di essere studiata da diverse prospettive, inclusa quella artistica.
G.S.M.: Molti dei protagonisti del libro, pur smettendo di “fare arte” in senso stretto, hanno continuato a mantenere un legame con il mondo dell’arte (pensiamo a Duchamp o a Saltz). Secondo lei, è davvero possibile smettere del tutto di essere artisti, o la dimensione artistica continua comunque a sopravvivere, magari sotto altre forme?
Penso che la condizione di artista non venga meno nel momento in cui si decide di interrompere la propria attività. Credo che essere artista non sia soltanto un mestiere ma un orizzonte identitario che abbraccia la professione, la vita privata, il tempo non occupato dal lavoro, la sfera emotiva. Pertanto reputo che il dropout, applicato alla sfera artistica, abbia un’eco ancora più vasta ed effetti che non coinvolgono solo l’ambito professionale.
G.S.M.: E’ possibile ipotizzare un atteggiamento di sublimazione artistica in uno stato di contemplazione dell’idea del Bello-artistico che non urge più configurare in oggetto-opera?
Non credo nell’idea assoluta di Bello artistico e ritengo sia un concetto che nemmeno i protagonisti del mio saggio hanno perseguito. Penso, tuttavia, che l’azione artistica non esaurisca il suo potenziale nell’oggetto-opera ma lasci tracce evidenti anche quando l’opera non è tangibile – nel senso più ampio del termine. Basti pensare a Torno subito di Maurizio Cattelan: l’oggetto-opera, se così lo vogliamo definire, è l’azione artistica che, in questo e in altri casi, racchiude in sé le logiche sottrattive dello scarto di lato all’ultimo momento. Logiche attorno alle quali la poetica di Cattelan si è strutturata nell’arco dei decenni.