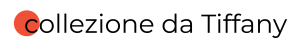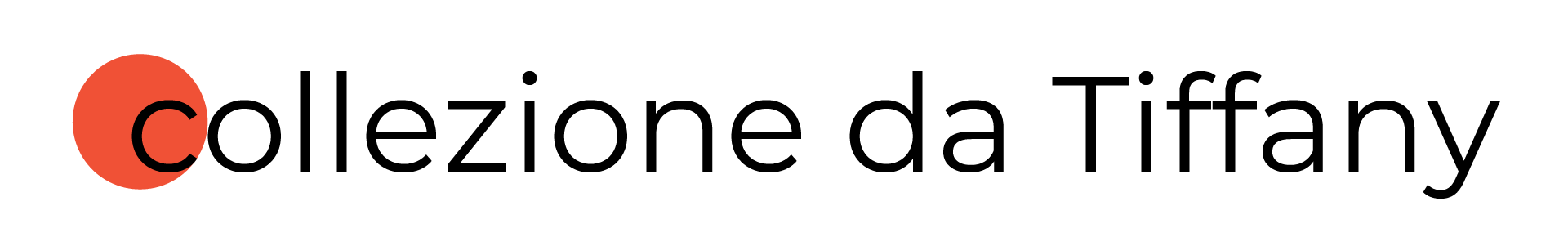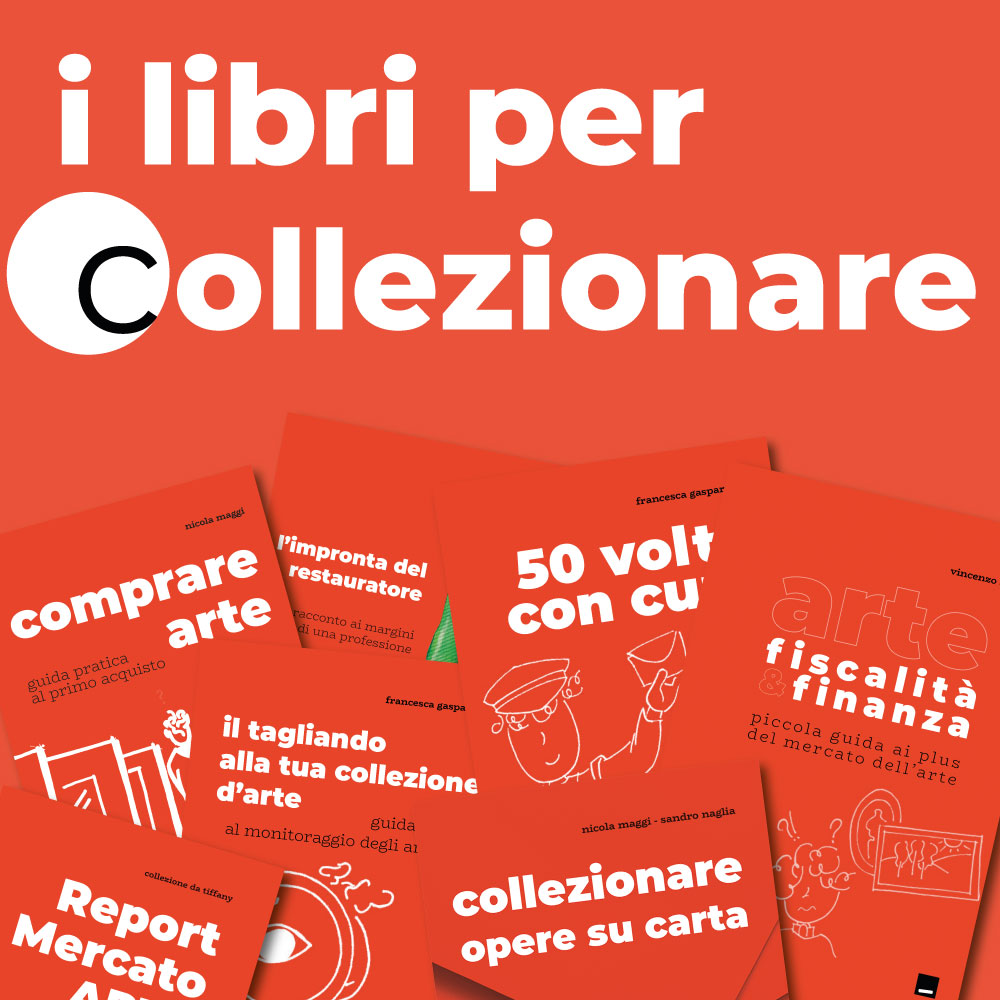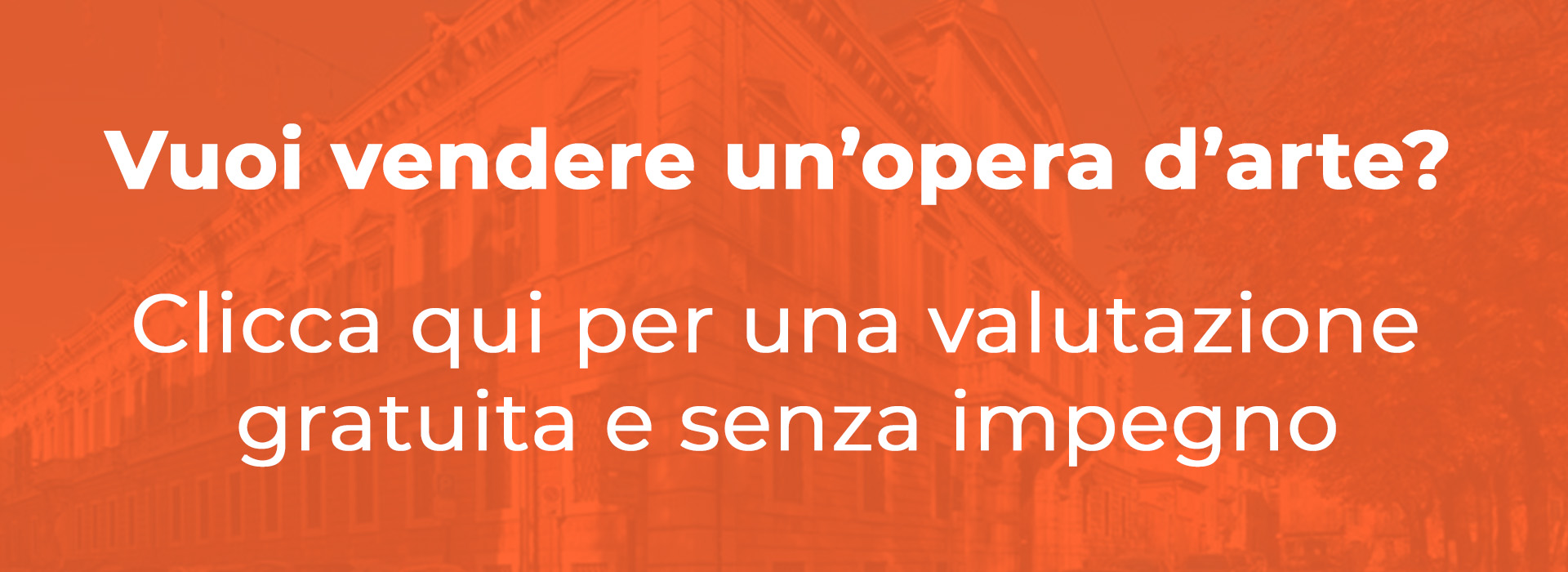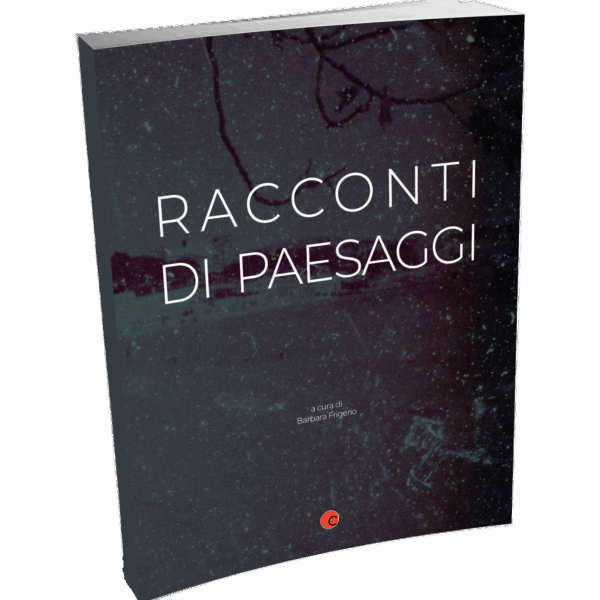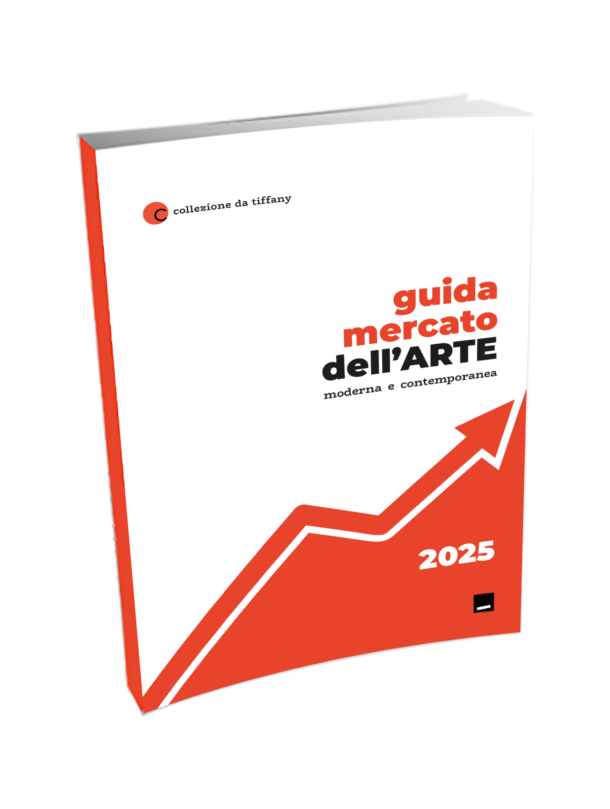Negli ultimi trent’anni, il settore delle case d’asta ha vissuto una trasformazione radicale. Se un tempo il mercato era fortemente legato alla dimensione fisica e ai rapporti di fiducia tra venditori e acquirenti, oggi il digitale ha cambiato profondamente le dinamiche di acquisto e vendita. Matteo Cambi, alla guida della Casa d’Aste Cambi, racconta come la sua famiglia è entrata in questo mondo, come il mercato si è evoluto e quali sono le nuove sfide per collezionisti e operatori del settore.
G.F.: Come nasce la Casa d’Aste Cambi?
M.C.: La nostra famiglia ha sempre avuto una forte connessione con l’antiquariato e l’arte antica. Negli anni ’90, oltre alla nostra attività di negozio, abbiamo iniziato a collaborare con una casa d’aste genovese. Con il tempo, abbiamo maturato il desiderio di fondare una nostra realtà, che è nata alla fine del decennio.
All’inizio ci concentravamo soprattutto sull’arredo antico, ma ci siamo presto ispirati al modello anglosassone, suddividendo le aste per categorie specifiche. Una delle prime fu quella dedicata ai libri, poi ci siamo focalizzati sulle arti decorative del Novecento, dai vetri Gallé e Murano alle statuine. Nel tempo, abbiamo ampliato il nostro raggio d’azione, includendo gioielli, orologi, vino, arte moderna e design.
Ogni tanto ci piace sperimentare: negli ultimi anni abbiamo organizzato aste di Naturalia, un settore che ha attirato molta attenzione mediatica, specialmente con la vendita di fossili di dinosauri. Non ai livelli di Sotheby’s, che ha battuto esemplari per 50 milioni di dollari, ma anche i nostri piccoli dinosauri hanno fatto parlare di sé!
G.F.: Come è cambiato il mondo delle case d’asta negli ultimi trent’anni?
M.C.: Tutto è cambiato. Alla fine degli anni ’90, le aste erano eventi molto locali: venditori e acquirenti erano spesso della stessa area geografica, magari Milano o la Toscana. Le sale erano gremite, e il rapporto fisico con l’opera era imprescindibile.
Oggi il mercato è globale e la presenza in sala è drasticamente ridotta. Da battitore, è strano vedere una sala semivuota, ma ormai la maggior parte delle vendite avviene online.
All’inizio, l’idea di acquistare arte senza vederla dal vivo sembrava impensabile. Il principio cardine era che un’opera andasse osservata, toccata, valutata. Eppure, oggi il 90-95% degli acquisti avviene tramite immagini. Questo da un lato ha reso il mercato più accessibile e ampio, dall’altro ha fatto perdere il contatto diretto con le opere e con chi le vende.
G.F.: Come mai oggi le persone si fidano ad acquistare solo dalle immagini?
M.C.: Negli anni è cambiato il modo di collezionare. Un tempo, il rapporto con l’arte era più diretto e costruito nel tempo: c’erano clienti abituali che ogni sera passavano a trovare il gallerista di fiducia e finivano per acquistare un’opera dopo l’altra.
Oggi si compra in modo più veloce e immediato, spesso da smartphone, con un meccanismo simile a quello dei social. Anche la fiducia si è trasformata: prima si basava su relazioni personali, ora su recensioni e reputazione online e rapporti a distanza.
Anche chi vende deve fidarsi: spesso si affida a un mediatore, un gallerista di riferimento, che lo indirizza alla casa d’aste giusta. Per chi compra, le aste sono una realtà abituale, mentre chi vende (spesso) lo fa una o due volte nella vita e può avere più timori.
G.F.: Oggi è più difficile rispetto al passato trovare lotti di valore?
M.C.: Sicuramente sì, perché i lotti davvero interessanti sono sempre meno. Un tempo, un oggetto era considerato prezioso semplicemente perché antico o artistico, mentre oggi questo criterio non è più sufficiente.
La selezione del “bello” è diventata molto più complessa: nulla sembra mai abbastanza bello, interessante o conveniente. In passato, era più comune trovare in asta pezzi con prezzi molto inferiori al loro reale valore, perché c’era meno consapevolezza e meno strumenti per valutarli.
Le aste di un tempo vendevano praticamente tutto: chi affidava un oggetto lo lasciava al mercato, senza troppi calcoli. Oggi, con internet, i database dei risultati d’asta e strumenti come Google Lens, è molto più facile confrontare prezzi e provenienze.
Questo rende più difficile trovare pezzi a prezzi davvero competitivi per creare una vera gara d’asta. Le case d’asta devono calibrare con molta attenzione il prezzo di partenza per attrarre compratori e garantire la vendita.
G.F.: Ma la concorrenza tra le case d’asta nella ricerca dei lotti è aumentata?
M.C.: Sì e no. È vero che il numero di case d’asta è aumentato e che oggi tutti operano su mercati diversi, quindi un oggetto trovato a Roma potrebbe essere venduto ovunque.
Tuttavia, è venuto a mancare un concorrente storico: il mercante. Un tempo, le case d’asta proponevano un milione per un’opera, sperando di venderla a due in asta, ma spesso arrivava il mercante, che la sera stessa della visita offriva uno e mezzo e se la portava via.
Oggi i mercanti comprano meno: hanno magazzini pieni e meno liquidità. Questo ha ampliato la disponibilità di materiale per le case d’asta. Certo, le opere di grande prestigio sono più difficili da reperire, e per questo ne vendiamo solo un paio di volte l’anno.
Per gli oggetti di fascia media e bassa, invece, l’offerta è molto ampia, tanto che potremmo organizzare aste minori quasi ogni giorno.
G.F.: La strategia vincente è quindi quella di puntare sempre di più sulla qualità, alzando il livello dei lotti?
M.C.: Sì, in teoria sarebbe la strategia vincente, ma la nostra politica è sempre stata quella di soddisfare il venditore a 360 gradi. Per questo, nel tempo, abbiamo aperto diversi dipartimenti, anche in settori che magari non sono il nostro core business. Non abbiamo scelto di specializzarci in un’unica fascia di prezzo o in un solo ambito.
Oggi ci sono tre o quattro settori che funzionano davvero e sono gli orologi, i gioielli, il moderno (anche se un po’ meno) e il contemporaneo. Se si dovesse fare una scelta, sarebbero questi i campi su cui puntare, perché il 90% dei top lot delle case d’aste è lì.
Poi, siccome tutti guardiamo cosa fanno i concorrenti, se una casa d’aste organizza un’asta da un milione di euro di vini, viene naturale chiedersi: perché non farla anche noi? Ci sono settori che permettono la moltiplicazione delle proposte, come il design, dove oggi tutti fanno aste e qualcosa si vende sempre. E poi ci sono settori in cui il mercato è più stretto e non lo puoi espandere a piacere.
G.F.: Ultimamente il settore degli orologi sta andando molto bene. Perché?
M.C.: Una volta si comprava arte antica e si puntava sul Rinascimento, poi il secolo d’oro è diventato il Settecento, poi l’Ottocento, poi il Novecento, e così via.
Oggi, chi compra l’antico ha tra gli 80 e i 90 anni. La fascia media si sposta sul moderno. I giovani sotto i 50 anni, salvo poche eccezioni, comprano pochissima arte. L’unico settore che attira davvero le nuove generazioni sono gli orologi.
Ci sono ventenni, trentenni e quarantenni che comprano orologi di mestiere, per investimento o per trading. È un po’ come se l’orologio avesse preso il posto dell’arte: prima la casa era un luogo di rappresentanza, oggi l’orologio si vede al ristorante, al polso, e diventa un argomento di conversazione. È un oggetto riconoscibile, tutti ne conoscono i modelli e i prezzi, e quindi se ne può parlare come si parla di vini o di gin.
G.F.: Tornando all’arte moderna e contemporanea, è cambiato qualcosa nel rapporto tra passione e investimento?
M.C.: È cambiato tantissimo. Prima chi comprava moderno lo faceva per passione. Chi ha comprato Fontana negli anni ’60 non poteva nemmeno immaginare che sarebbe arrivato a certe cifre. Lo prendeva perché gli piaceva, perché voleva qualcosa di moderno, perché un gallerista gliene aveva parlato, perché l’amico lo aveva già e voleva essere al passo, perché c’erano le mostre. Il discorso economico era marginale.
Oggi l’aspetto finanziario è entrato nel mercato dell’arte in modo molto più profondo. Ci sono report, analisi, confronti, e chi compra guarda prima di tutto al valore economico. Se un artista comincia a salire, tutti lo vogliono, non perché piaccia davvero, ma perché il suo mercato sta crescendo.
Un caso recente è quello di Salvo. I suoi quadri erano considerati carini, divertenti, ma niente di più. Poi il suo mercato è esploso, e tutti lo hanno iniziato a cercare. Fino a qualche anno fa costava cinque, sette, diecimila euro, oggi è arrivato a cifre molto più alte. E quando succede una cosa del genere, il mercato si muove in massa: tutti lo vogliono perché tutti lo vogliono. Poi magari la bolla si sgonfia, come è successo con tanti altri artisti.
Oggi il meccanismo è questo: l’attenzione si concentra su un artista, il mercato sale, poi magari si stabilizza o crolla.
G.F.: Come sta andando il mercato dell’arte oggi?
M.C.: Il 2024 è stato un anno difficile a livello internazionale: Sotheby’s ha registrato un -30% e anche Christie’s ha subito cali significativi. In Italia, però, la situazione è stata diversa. Il nostro mercato è più piccolo e meno speculativo, quindi ha reagito con meno volatilità.
Per noi, il 2024 è stato il secondo miglior anno di sempre, dopo il 2022. Dopo un 2023 più incerto, quest’anno c’è stata una ripresa. Per questo guardiamo con ottimismo al futuro.
G.F.: Quali sono i vostri obiettivi per il 2025?
M.C.: Negli ultimi anni abbiamo puntato molto sulla logistica, un aspetto fondamentale nel mercato attuale. Se prima le case d’asta erano situate in posizioni prestigiose, oggi la presenza fisica conta meno.
Per questo abbiamo creato un grande centro logistico, trasformando un ex edificio industriale in un deposito moderno, con spazi dedicati per ogni categoria di oggetti e set fotografici professionali.
Oggi la casa d’aste non è più solo una galleria, ma una macchina organizzativa complessa, simile a un e-commerce. Dobbiamo gestire spedizioni in tutto il mondo e offrire un servizio efficiente. La tecnologia ha cambiato tutto, ma il rapporto di fiducia con il cliente resta il nostro punto di forza.