Molti amanti e studiosi di fotografia conoscono, almeno superficialmente, Walter Benjamin e il suo L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, del 1936. Meno noto è un saggio del filosofo tedesco di qualche anno prima (1931), che porta il titolo, a dire il vero ambizioso, di Piccola storia della fotografia.
La Piccola storia della fotografia è in realtà composta da due saggi diversi e non si propone, come si potrebbe erroneamente pensare dal titolo, come una vera e propria storia della fotografia. È, ciononostante, un testo davvero molto interessante, denso di spunti utili anche a noi che abitiamo la contemporaneità, ovvero un’epoca storica in cui la fotografia è diventata ormai qualcosa di pervasivo e onnipresente.
Come hobby, come selfie, come lavoro o come arte…
Oggi, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento del giorno ci troviamo, è facile incrociare il passo (e non lo sguardo) di persone intente a fotografare e fotografarsi, per poi condividere le proprie immagini sui social media. Nello stesso tempo, dai tempi di Benjamin ad oggi, la fotografia ha sempre più rivendicato il proprio status di medium espressivo in ambito artistico contemporaneo.
In sostanza, oggi ci troviamo di fronte a un doppio binario: da una parte la fotografia è qualcosa che tutti praticano con estrema facilità, producendo immagini destinate a perdersi facilmente; mentre dall’altro la fotografia si è conquistata sempre più un proprio posto in ciò che è considerato arte contemporanea.

La differenza tra le diverse concezioni di una stessa realtà, o meglio di due o più realtà tra loro molto differenti che sono indicate con la stessa parola (fotografia come hobby, fotografia come selfie, come lavoro di quelli che fanno le foto ai matrimoni o per le pubblicità e infine fotografia come arte) genera non poca confusione.
Quindi, esattamente di che cosa parliamo quando parliamo di fotografia? Il buon Walter Benjamin, ovviamente, non aveva la minima idea di questo tipo di problematica, che ai suoi tempi non poteva forse neppure essere immaginata dal più ardito visionario. Eppure, il suo testo sulla storia della fotografia fornisce spunti utilissimi per aiutarci a ripensare l’argomento e provare a dare una risposta al nostro quesito.
Tra creazione artistica e narrazione di vicende umane
La piccola storia della fotografia nasce da una riflessione diversa, ma simile alla situazione che noi viviamo ora. Benjamin distingue infatti la fotografia delle origini dalla fotografia dell’epoca industrializzata, riferendosi alla rivoluzione industriale dei primi del Novecento.
In questo contesto, Benjamin parla addirittura, già ai suoi tempi, di “declino della fotografia”. Insomma, la fotografia, per Benjamin, ha appena passato un periodo d’oro. Si è posta come quel mezzo tecnico capace di catturare l’immagine, di crearla, anzi, ex novo a partire dagli elementi disordinati che è possibile cogliere dalla realtà.
Giocando sapientemente con tempo, luce e spazio (sono alla fine questi i tre elementi basilari dell’immagine fotografica, deduciamo dalla lettura di Benjamin), la fotografia si situa fin dalla sua nascita, con i primi dagherrotipi, sul crinale tra tecnica e poiesi, tra creazione artistica e narrazione di vicende umane e storiche.
Le prime immagini fotografiche avevano due caratteristiche: in primo luogo, richiedevano un tempo ed un allestimento preciso per essere realizzate, e in secondo luogo, erano pezzi unici, dato che i dagherrotipi erano alquanto difficili da riprodurre e replicare.
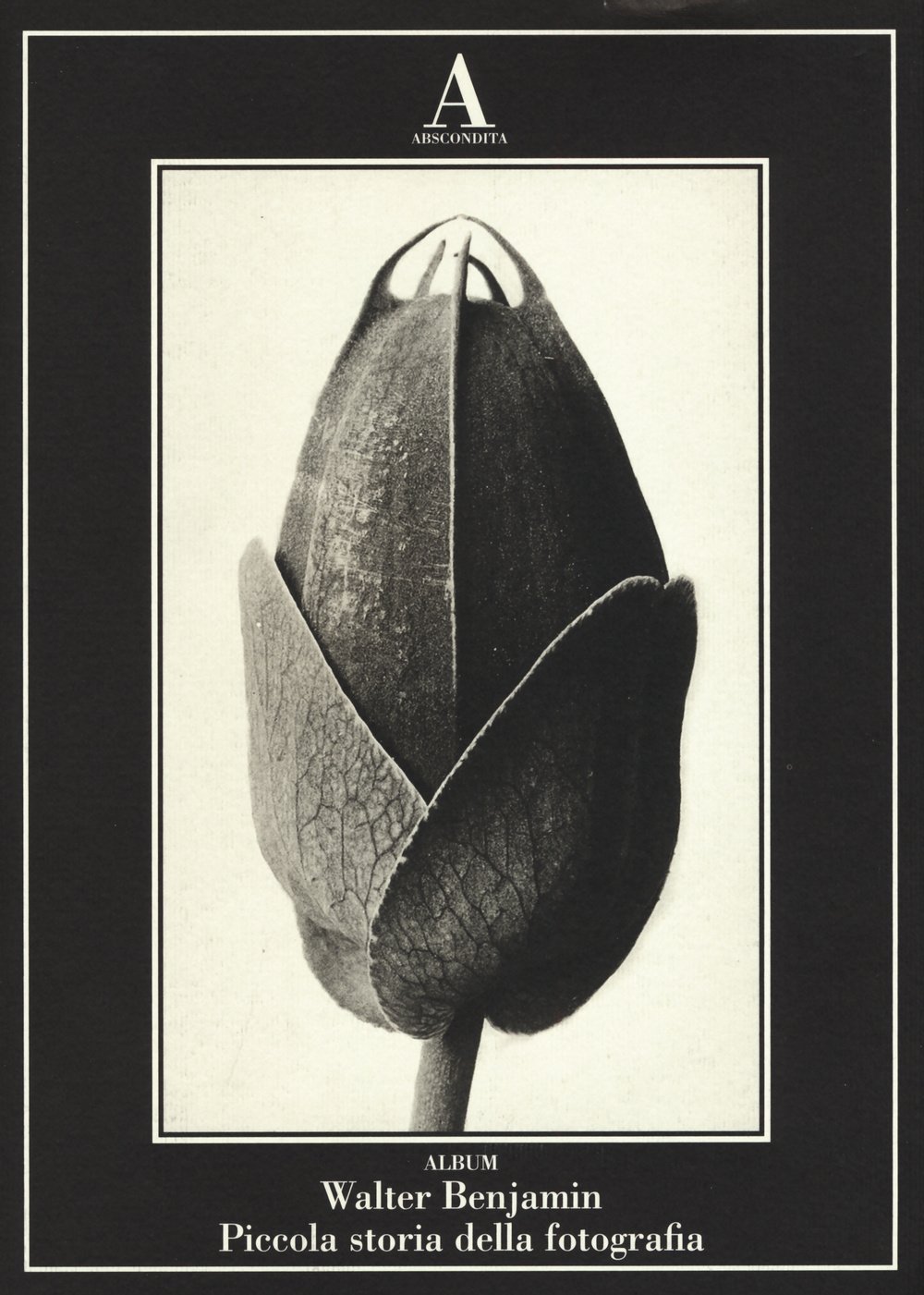
Con queste semplici affermazioni tocchiamo due punti cardine del pensiero di Benjamin riguardo alla fotografia: la riproducibilità o, al contrario, l’unicità dell’immagine e la questione del tempo che essa cattura, per fissarlo nell’immagine di un istante eterno.
Dal punto di vista di Benjamin il fatto che l’immagine sia riproducibile per mezzo della tecnica è insieme un bene e un male. È un male, perché insieme con l’unicità l’opera perde la sua aura, come dirà Benjamin nel saggio più famoso. Ma è anche un bene, perché permette la diffusione e quindi la democratizzazione delle immagini stesse.
Ma in che cosa si distingue, in concreto, una fotografia, per esempio di un volto umano, rispetto ad un ritratto dipinto ad olio?
Per Benjamin la differenza è enorme. Nell’un caso come nell’altro è rappresentata un’individualità, una persona, un volto. Ma mentre la pittura tende a universalizzare il suo oggetto, la fotografia invece porta con sé l’insopprimibile testimonianza di una identità precisa e inaggirabile. È proprio quella persona lì che vediamo nell’immagine, non semplicemente “un vecchio” o “un bambino”, ma una persona con una sua storia ritracciabile e narrabile.

Ciò renderà possibile schedare le persone, catalogarle secondo “tipi” umani (come andava in voga all’epoca, da Jung a Cassirer, passando per Simmel)?
Più o meno. Certo, dove Bloβfeldt fotografa le piante nelle loro fattezze simili a decori art nouveau, schedandole in un catalogo preciso, un lavoro simile è quello compiuto da Sander con gli esseri umani, con i suoi Uomini del XX secolo. Ma anche Atget, con le sue immagini di città deserte, con le loro strade spettrali e magiche, dove le vetrine dei negozi già lasciano intravedere le derive consumistiche della réclame, compie passi importanti nella stessa direzione: quella di narrare l’uomo del nuovo secolo, e il suo habitat, la città.
Mostrando e commentando fotografie, Benjamin fa anche due esempi illustri. Mostra una foto di Kafka, ripreso da piccolo, ad appena quattro anni, con in mano un cappello troppo grande, e una di Schelling, un ritratto nel quale le rughe del vecchio filosofo paiono echeggiare, nota Benjamin, le pieghe sinuose della sua giacca.
Schelling, sì, il filosofo idealista. Viene da chiedersi se Benjamin citi Schelling per caso, oppure se la citazione sia anche un sotteso rimando al pensiero dell’uomo che condivideva il Tübinger Stift (Seminario di Tubinga) con Hölderlin e Hegel. Ma Benjamin, come è nel suo stile, lascia la cosa a metà, come un suggerimento buttato lì per caso, e passa oltre. Noi invece torniamo alla nostra domanda iniziale.
Di che cosa parliamo quando parliamo di fotografia?
Benjamin ha una sua risposta a questa domanda, ma come è nel personaggio, non si tratta di una risposta univoca, che pone fine in modo inequivocabile e apodittico alla discussione o alla ricerca. Al contrario, la sua è una risposta che sembra fatta apposta per aprire nuove domande, e da quelle domande altre domande e altre ancora.
Situandosi a metà strada tra un sì e un no, tra un dire e un non dire, tra una testimonianza e un tradimento, una memoria e una dimenticanza, l’immagine fotografica per Benjamin si qualifica come dialettica. Che cosa vuol dire questo?
Ma per capire Benjamin dobbiamo prima di tutto sgombrare il campo da un pregiudizio insidioso – che è di origine hegeliana, anche se chi ce l’ha non lo sa… Il pregiudizio è quello di pensare che la dialettica, intesa come gioco di forze contrastanti, ancor prima che come procedimento logico e analitico, debba per forza tendere a una risoluzione, debba per forza essere ricomposta.
Ma non è la conciliazione degli opposti che interessa Benjamin, quanto il situarsi sul punto esatto in cui la tensione tra i due termini opposti della dialettica è massima. Stare lì, in quel punto della corda tesa, dove rischia di spezzarsi. Fin quando non raggiungiamo un punto magico, in cui le trazioni si attenuano, in un momento di incantato silenzio.
Proprio lì, nel bel mezzo della contraddizione, Benjamin ci accompagna in seno a una verità tanto profonda quanto inafferrabile, che non ha alcuna voglia di lasciarsi dire a parole. È la verità contraddittoria ed effimera, ma anche intensamente poetica e ricca di effetti, dell’immagine fotografica al suo declino.






