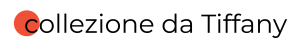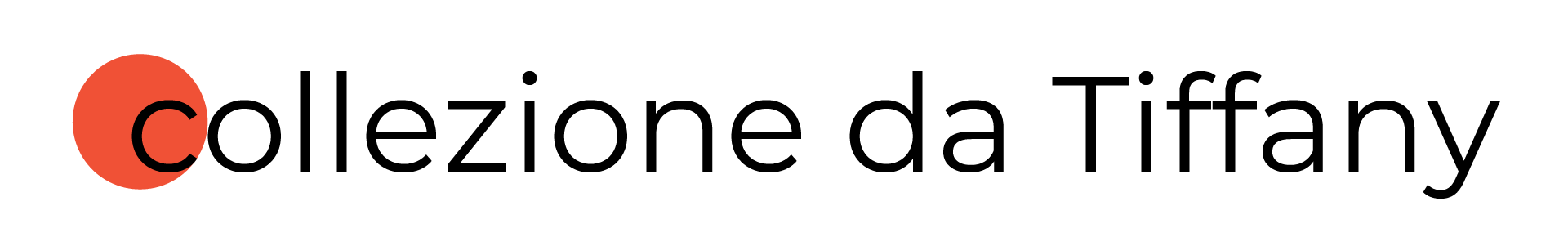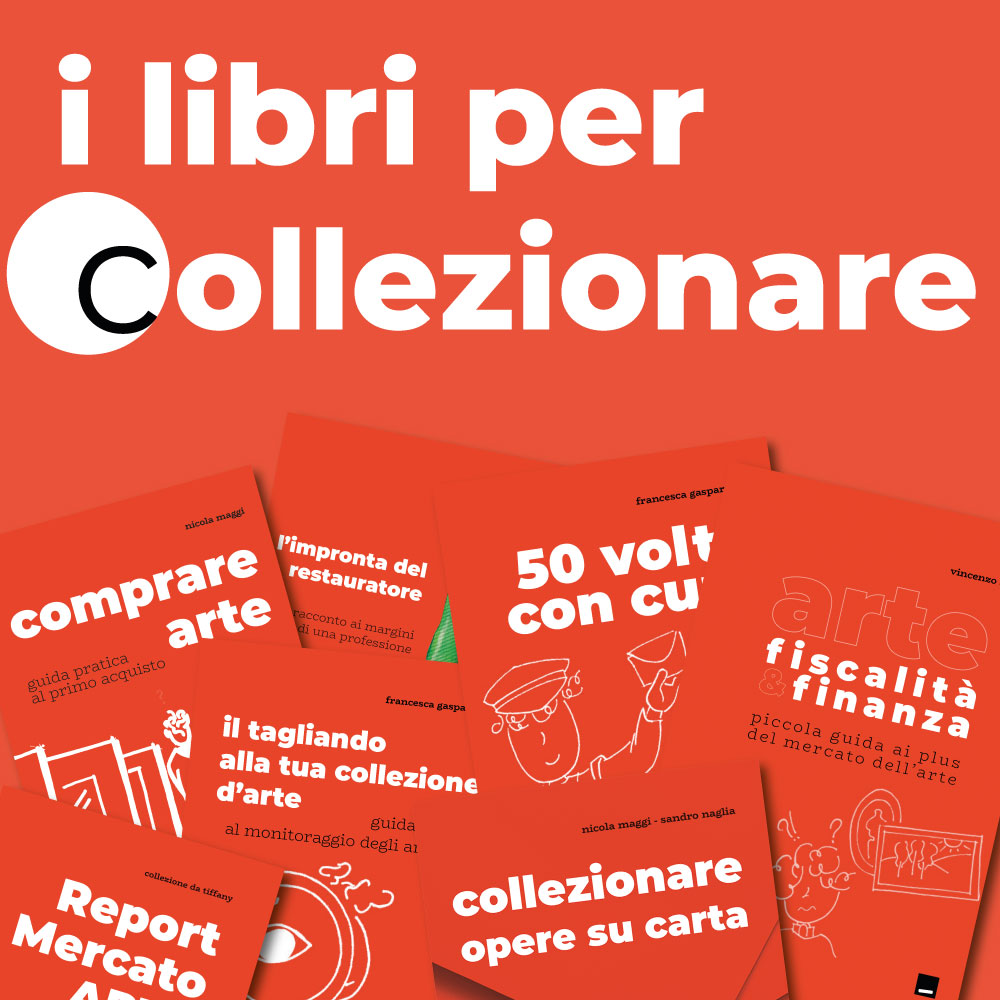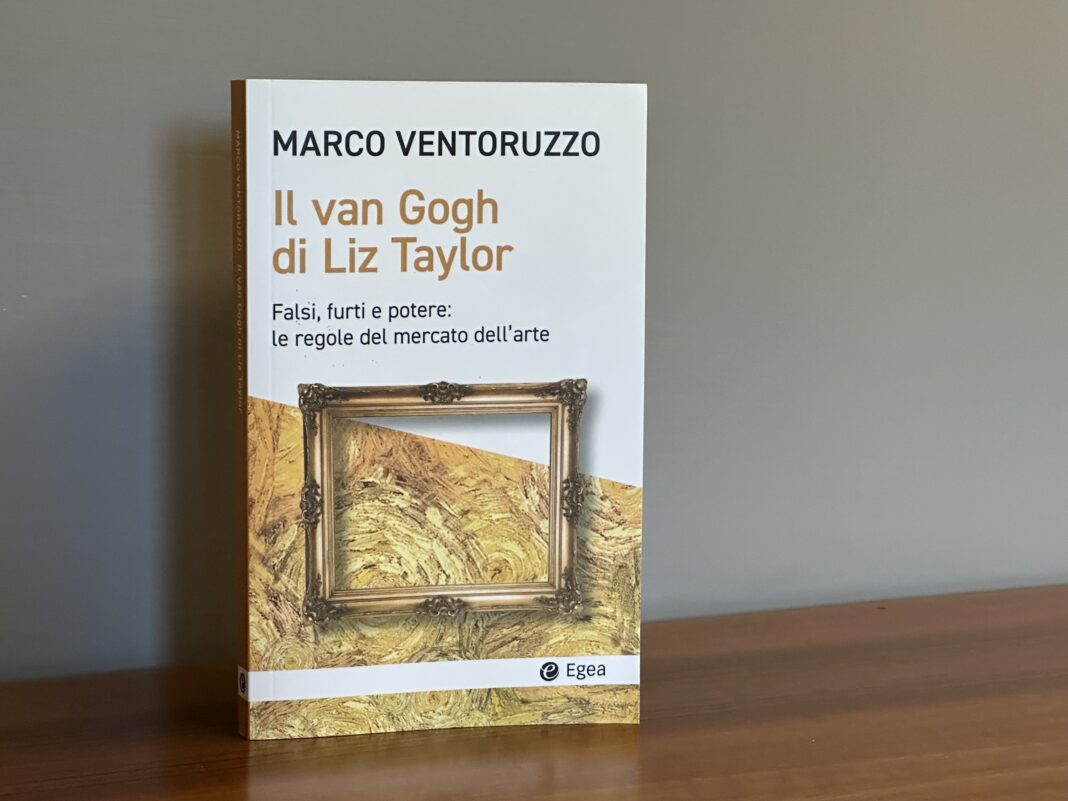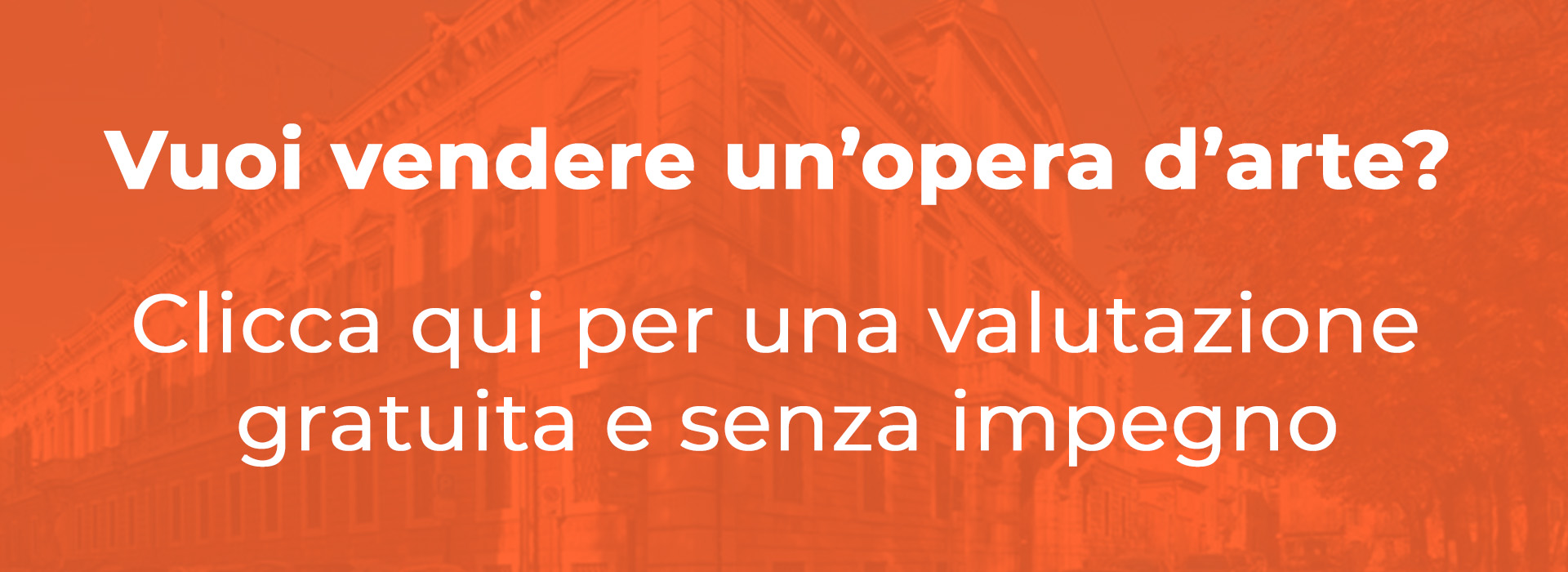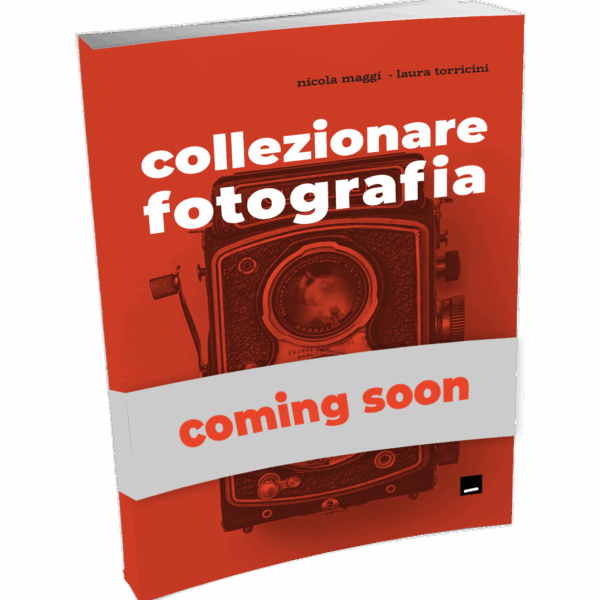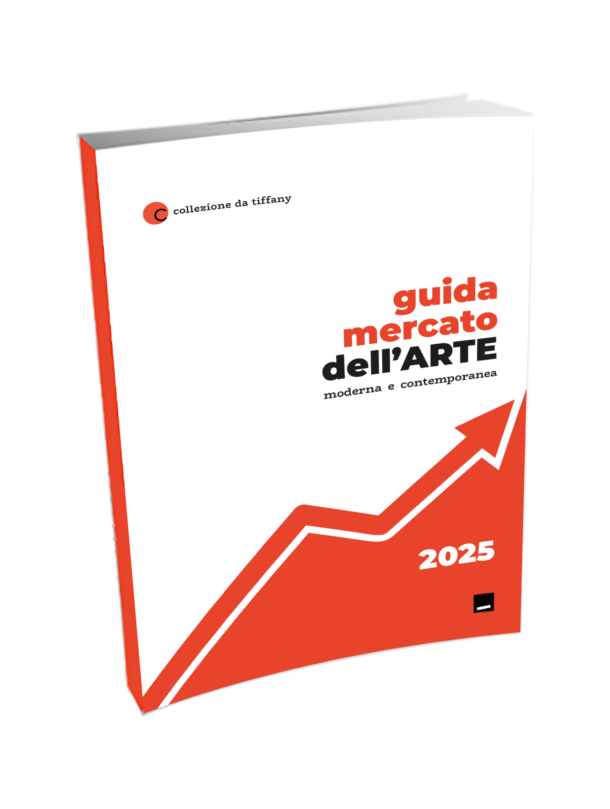Un viaggio tra diritto e arte: quando la legge incontra le tele e i marmi
Marco Ventoruzzo, giurista e docente presso l’Università Bocconi, esplora nel suo ultimo lavoro editoriale “Il Van Gogh di Liz Taylor” il delicato intreccio tra diritto e arti figurative.
Edito da Egea, il volume si propone come una guida, affascinante e accessibile, per comprendere i meccanismi giuridici, storici e culturali che regolano il mercato dell’arte. Suddiviso in sette capitoli tematici, il libro si articola come una conversazione leggera e piacevole, arricchita da aneddoti storici e giuridici che coinvolgono lettori appassionati d’arte e di diritto.
Un approccio multidisciplinare: dal diritto all’intuizione
Fin dalla premessa, l’autore chiarisce il proprio intento: proporre un’analisi non accademica, ma certamente rigorosa, che guidi il lettore a riflettere sul lato affascinante del diritto applicato al mondo dell’arte.
Attraverso un’ampia gamma di casi giudiziari e di racconti, Ventoruzzo affronta temi come la definizione di arte, la censura, i contratti d’opera, il mercato, i falsi, i furti e persino la rappresentazione del diritto nelle opere artistiche.
Il capitolo dedicato al falso artistico è accattivante per la ricchezza di dettagli tecnici e storici. Vi si esplorano le tre principali metodologie per identificare un falso: l’indagine documentale, quella scientifica e l’approccio stilistico.
Da analisi chimiche sui pigmenti a verifiche calligrafiche delle firme, l’autore descrive tecniche degne di un romanzo giallo, evidenziando come scienziati e critici d’arte collaborino per svelare la natura di opere controverse. Il racconto del kouros greco, acquistato dal Getty Museum e sospettato di essere una contraffazione, è un esempio brillante del “sesto senso” necessario per individuare un falso.
Il mercato dell’arte tra passato e presente
Particolarmente interessante è il capitolo dedicato ai contratti d’opera, che traccia l’evoluzione del rapporto tra artisti e committenti. Se in epoca rinascimentale gli artisti erano vincolati a rigidi contratti che specificavano materiali e soggetti, oggi essi godono di maggiore libertà creativa, benché subordinati alle logiche di un mercato dominato da galleristi, critici e collezionisti.
Si apprende dalla lettura come fattori economici e tecnologici abbiano influenzato il mondo dell’arte, dall’uso del costoso pigmento blu oltremare nei manti della Vergine Maria fino alla democratizzazione dei materiali pittorici nell’era industriale.
Censura e diritto nell’arte
La censura è un altro argomento che l’autore affronta con profondità e sensibilità. Ventoruzzo ripercorre i casi in cui la legge ha interferito con la libertà artistica, ponendo interrogativi su quanto sia labile il confine tra espressione creativa e violazione delle norme sociali o morali.
Dalle opere provocatorie di epoche passate alle polemiche contemporanee su performance e installazioni, l’autore ci invita a riflettere sul ruolo delle istituzioni e sulla natura soggettiva del concetto di “offesa”.
Uno stile coinvolgente e mai accademico
Ciò che rende Il Van Gogh di Liz Taylor una lettura speciale è lo stile di Ventoruzzo: pur trattando argomenti complessi di natura interdisciplinare, l’autore riesce a mantenere la narrazione fluida e accessibile.
Il libro è ricco di curiosità e di episodi che catturano l’attenzione del lettore, dalla vendita di opere “rubate” a questioni di copyright legate all’arte digitale.
Un’opera che unisce cultura, curiosità e riflessione
Il Van Gogh di Liz Taylor non è solo un saggio sul diritto e sull’arte: è un invito a scoprire i legami nascosti tra questi due mondi, spesso ritenuti distanti che in realtà si influenzano e interagiscono in modo sorprendente.
Con uno stile coinvolgente, Marco Ventoruzzo offre ai lettori una visione completa e affascinante del mercato dell’arte e delle regole che lo governano.
Il libro è consigliato non solo ai giuristi o agli appassionati d’arte, ma a chiunque voglia esplorare il potere della creatività, i suoi limiti e i suoi significati più profondi.
Abbiamo avuto modo di intervistare l’autore che ha così risposto alle nostre domande.
GSM: Il libro affronta il tema del rapporto tra arte e diritto attraverso la narrazione e l’esame di casi giudiziari e di controversie storiche. Qual è stato, secondo lei, il caso più emblematico che ha trovato durante la sua ricerca e che meglio rappresenta la complessità del mercato dell’arte?
MV: Difficile sceglierne uno, innanzitutto perché la complessità è dovuta alla stessa natura sfaccettata del mercato che, anche limitandosi alle sole vendite di opere, impone di distinguere almeno le commissioni, le aste e le vendite tra privati fuori dal meccanismo d’asta. Inoltre, arte, diritto e mercato evolvono nel tempo e quello che è importante e controverso oggi potrebbe non esserlo domani.
Vi è poi una dimensione geografica: sebbene esistano alcuni principi validi a livello transnazionale, su molte questioni ordinamenti diversi prevedono soluzioni non identiche. Non mi sottraggo però al gioco, e scelgo una delle vicende con cui si apre il libro, nel capitolo dedicato alla definizione di prodotto artistico per il diritto.
È il caso della statua metallica di Brâncuşi nota come “Uccello nello spazio”, che alla dogana USA venne inizialmente classificata come prodotto industriale, applicando tariffe di importazione più alte. Siamo negli anni Venti del secolo scorso e ne nacque un caso che arrivò fino alla Corte Suprema nel quale si discusse appunto di come si può definire l’arte.
La decisione mi piace perché affronta con gli occhiali del giurista un problema antico e difficile anche filosoficamente, calandolo nel periodo delle avanguardie non figurative, poco dopo la grande rottura degli Impressionisti. Non svelo però chi vinse la causa, se l’artista o il governo americano.
GSM: Nel capitolo dedicato al falso, sottolinea l’importanza della collaborazione tra storici dell’arte e scienziati per svelare imitazioni. Crede che la tecnologia, come l’intelligenza artificiale, possa rivoluzionare ulteriormente la lotta contro le contraffazioni?
MV: Certamente può aiutare, ma può aiutare anche i falsari, oltre a porre – anche per chi opera in buona fede – nuovi problemi sul confine tra originalità e imitazione. Basti pensare a opere prodotte da sistemi di intelligenza artificiale non copiate ma realizzate a costi bassissimi seguendo lo stile caratteristico di un particolare artista.
In sé la tecnologia è neutra, come un martello: posso usarlo per costruire una casa o per uccidere. Proibizioni draconiane o libertà totali raramente funzionano e comunque non funzionano a lungo: servono regole.
GSM: Non pensa che oggi il diritto dovrà occuparsi di una nuova fattispecie nel mondo dell’arte, diversa dalla falsificazione dell’opera? Si tratta della falsificazione dell’artista ovvero del “lancio commerciale” da parte di potenti e facoltose gallerie private che agiscono in concorso con importanti strutture pubbliche per “imporre” un artista ad alte quotazioni sul mercato, artista spesso, troppo spesso, poi abbandonato ad un meritato declino.
MV: È sicuramente un grosso problema e peraltro nell’armamentario di simili strategie si aggiungono oggi i social media che con la loro insidiosa apparenza di democrazia possono naturalmente essere manipolati e distorcere l’informazione. Eccessive concentrazioni di potere (politico, economico, mediatico, culturale) devono essere sempre evitate o almeno attentamente disciplinate.
Gli strumenti giuridici spesso ci sono ma occorre adattarli alle mutate condizioni socioeconomiche e serve anche maggiore – e più profonda – capacità critica del grande pubblico. Senza voler sminuire l’attualità di questi problemi che le crescenti disuguaglianze possano esasperare, non dimentichiamo però che le luci e ombre dell’animo umano sono sempre le stesse e che nel passato non sono affatto mancati abusi e manipolazioni, sebbene in forme e da parte di soggetti diversi.
Per buona parte della storia dell’umanità solo pochi, ricchissimi mecenati potevano pagare la realizzazione di opere d’arte, influenzandone però il programma. Nel volume racconto la storia di come Scipione Borghese si ingegnò, non sempre in modo irreprensibile, per accaparrarsi i capolavori di Caravaggio.
Va d’altronde riconosciuto, come forse la sua domanda sottintende che questi grandi personaggi della storia erano, quantomeno per gusto, sensibilità e finalità un poco più lungimiranti e forse più nobili di chi ordisce moderne campagne di marketing ai limiti dell’aggiotaggio artistico.