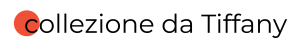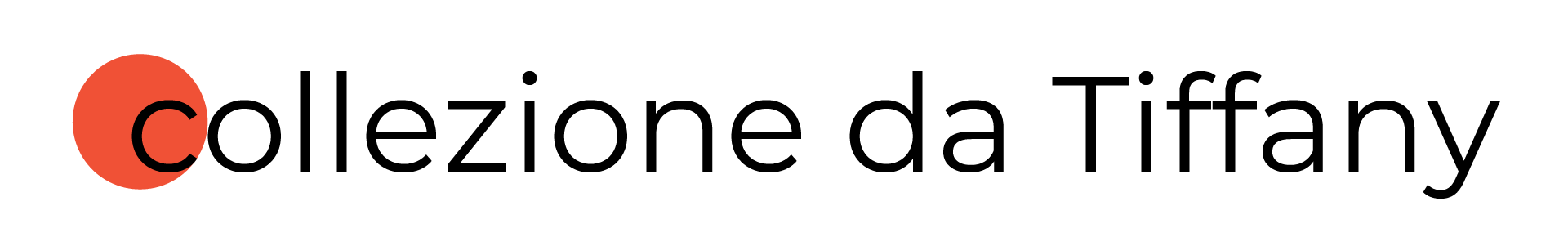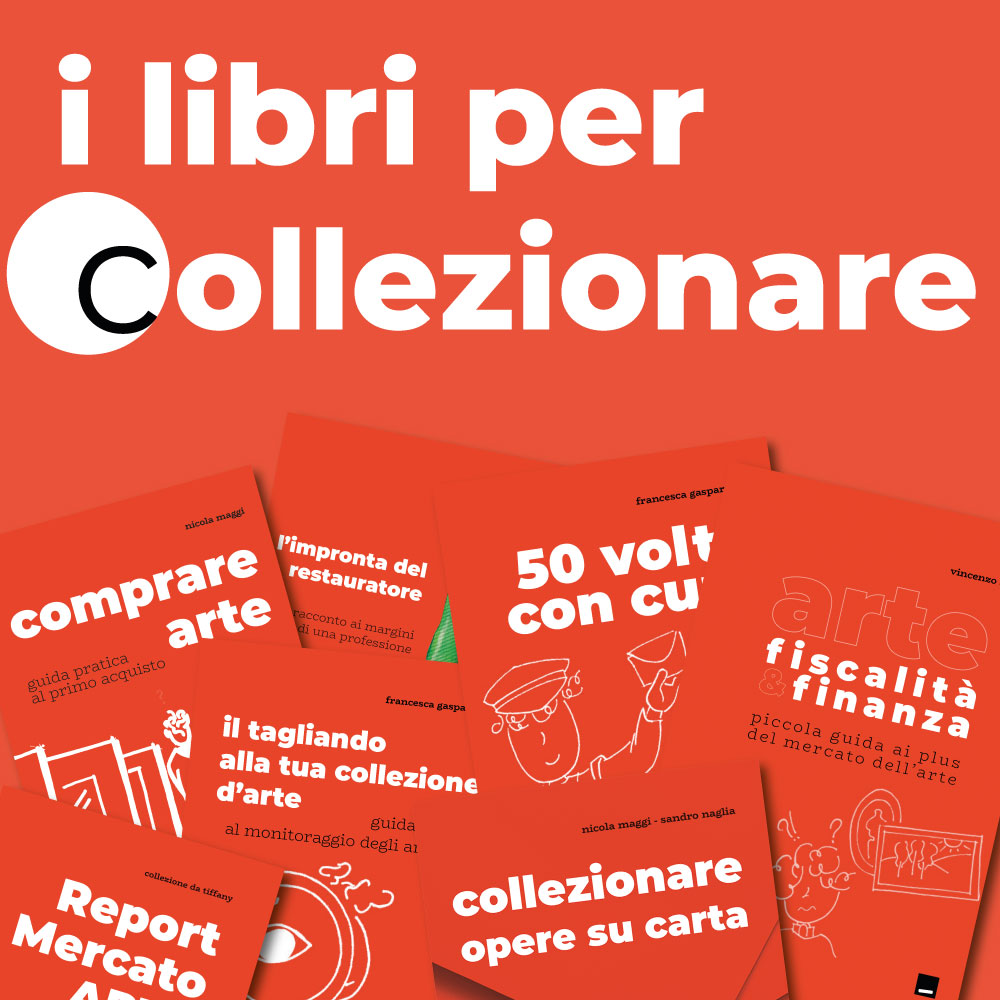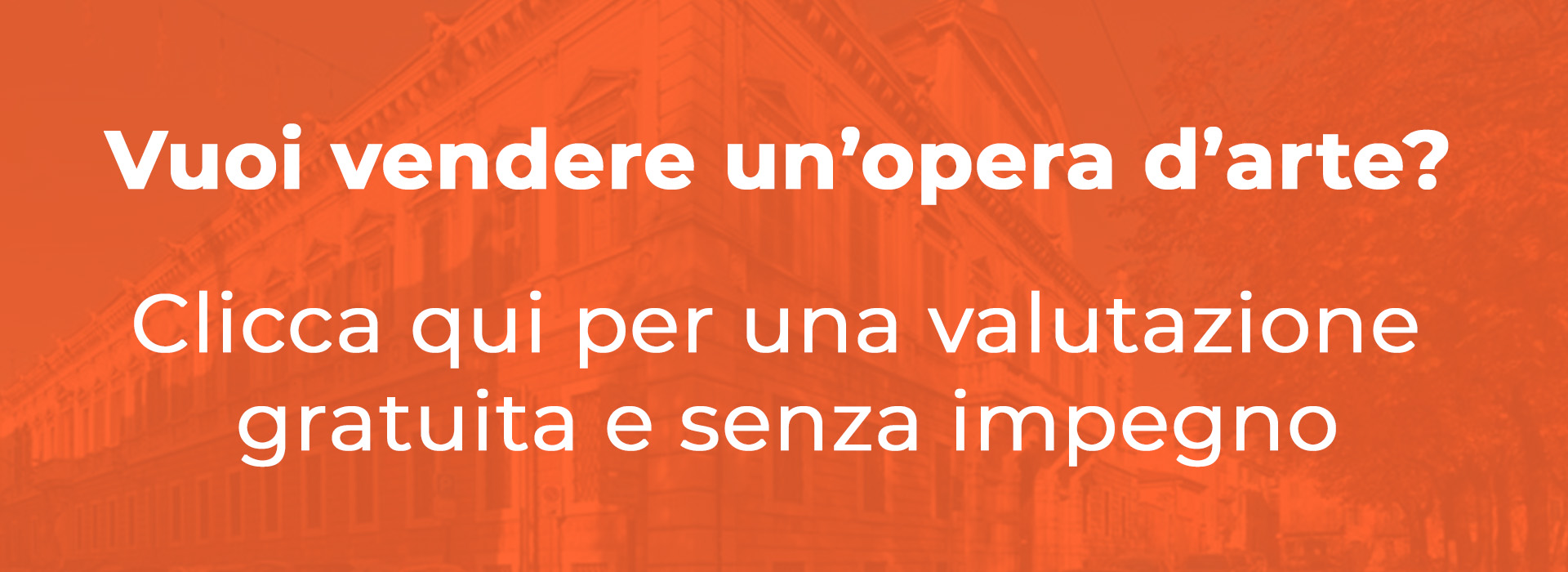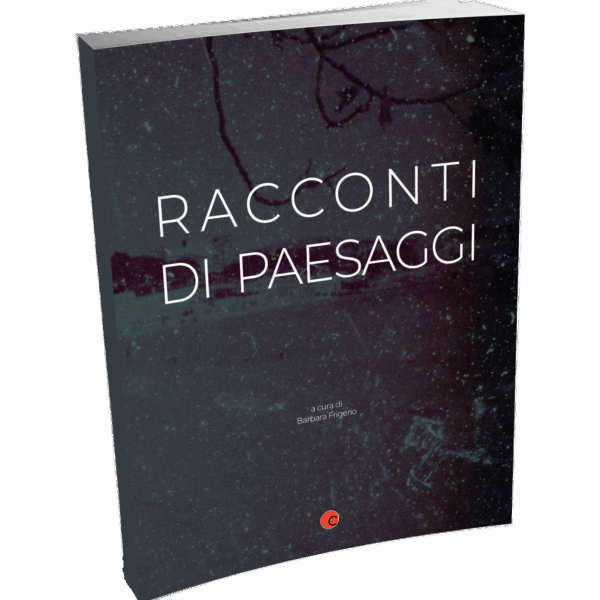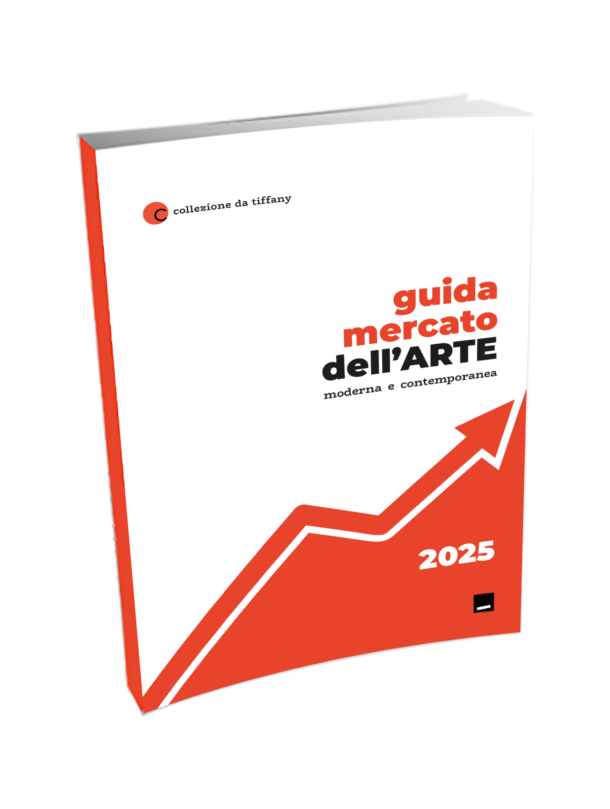Di recente sono stato invitato a partecipare a un convegno sul patrimonio culturale come fonte di valore economico e sociale, inserito in una rassegna dal titolo “Giornate di tutela economico-finanziaria e sociale”. All’interno di un contesto tanto serio, mi era stato chiesto di parlare del restauro come racconto e come responsabilità sociale: esattamente ciò che da cinque anni cerco di fare con i miei interventi su questo blog. Al pubblico che mi ascoltava ho provato a trasmettere il valore della professione del restauratore nel modo seguente.
A metà degli anni Novanta, Alessandro Conti — autore di una Storia del restauro che rimane una pietra miliare insuperata, e che nessuno si è mai assunto il rischio di superare — scriveva:
“Il pubblico del restauro era, una o due generazioni fa, quello degli storici dell’arte. Il massimo a cui un Pelliccioli poteva aspirare era la stima di Roberto Longhi o la segnalazione in termini positivi del suo lavoro sulla Cena di Leonardo da parte di Berenson.”
Negli anni in cui Conti scriveva, le cose erano evidentemente cambiate. Continua infatti:
“Vi è poi, grazie alla stampa di informazione, la tendenza a volere che ogni restauro riveli aspetti inediti di maestri e opere d’arte, aprendo nuovi orizzonti alla storia dell’arte. Ricordo un articolo di giornale uscito subito dopo la pulitura della Nascita di Venere di Botticelli, nel 1987, che descriveva l’oro in conchiglia fra i capelli in una maniera tale da dover pensare a un serio danno; l’incolto cronista, semplicemente, non aveva mai osservato con attenzione il dipinto prima del restauro, e dava come eclatanti novità quelle che non erano che le peculiarità tecniche della grande tela, sia prima che dopo l’intervento.”
Con queste osservazioni si evidenziano, in buona sostanza, le difficoltà che il restauro e, più specificamente, la professionalità del restauratore hanno avuto — e continuano ad avere — nel presentarsi senza complessi di inferiorità rispetto a storici dell’arte, architetti e archeologi.
Chi è, dunque, un restauratore? Cosa lo differenzia da un qualunque altro artigiano? Qual è il suo campo d’azione e in cosa si concretizza l’attività del suo intelletto?
Andiamo alle origini. Nel 1866, il conte Giovanni Secco Suardo di Bergamo scriveva nel suo Manuale ragionato per la parte meccanica dell’Arte del Restauratore di dipinti che il perfetto restauratore
“debb’essere un uomo dotato di un numero non comune di cognizioni, e che aver deve disposizioni speciali per tutti i rami nei quali dividesi l’arte sua.”
Il tipo di restauratore cui si fa riferimento è quello di dipinti, essendo la tela dipinta, in quegli anni, l’oggetto artistico per eccellenza. Durante la sua formazione, il conte aveva compiuto un ampio tour in Europa, visitando gallerie e quadrerie, e raccogliendo in un taccuino le sue osservazioni personali sullo stato di conservazione dei dipinti che vi aveva visto.
“Il miglior ristauro è quello che meno si scorge” — prosegue l’introduzione al manuale.
Un concetto dalla formulazione ambigua, la cui conciliabilità con i successivi principi del minimo intervento e della riconoscibilità del restauro resta tutt’altro che scontata.
A proposito di tali principi, la via italiana al restauro — quella nata dalle formulazioni teoriche di Cesare Brandi, per intenderci — ha elaborato, nel dopoguerra, una serie di procedure affinché il ritocco pittorico fosse individuabile ma non perturbante: dal rigatino alla selezione cromatica, soluzioni che sono insieme croce e delizia per il restauratore che le esegue e per il fruitore che le osserva. Questo approccio ha prodotto risultati talvolta eccellenti, talvolta di difficile comprensione, frutto — secondo alcuni — di un atteggiamento troppo idealista e poco concreto nei confronti della materia.
Se dovessimo restituire con un’immagine poetica la figura del restauratore, potremmo pensarla come la storia di una mano, combattuta tra il mostrarsi, il nascondersi o lo sparire del tutto: è l’impronta del restauratore, il tocco che traduce le formulazioni teoriche nella materia dell’opera.
Perché è tradizionalmente la materia il “campo di battaglia” del restauro, una pratica che non può arrestarsi alla sola teoria.
La materia, plasmata dall’artista in modo unico e irripetibile, richiede un approccio fondato su una solida preparazione teorica ma aperto a ogni possibile modalità di intervento. Ne consegue che il restauro non potrà mai essere un’operazione perfettamente standardizzata — poiché se lo fosse, correrebbe il rischio di sfociare nella falsificazione. Allo stesso tempo, però, non può essere una pratica affidata all’inventiva personale. Ciò che serve, ciò che dà valore al restauro, è un buon equilibrio.
Nel 1948, Roberto Longhi pubblicava un articolo che iniziava così:
“Qualcosa non va, nel governo dell’arte italiana, e proprio ne’ suoi congegni più delicati. Novelle corrono sulle ripetute malefatte di una pratica che, nell’ambito dell’antica arte figurativa, è di somma responsabilità: la pratica del restauro.”
Un giudizio poco lusinghiero, dettato dalla sostanziale incultura della materia e dall’assenza, all’epoca, di un organismo centrale realmente in grado di supervisionare i restauri e soprattutto i restauratori italiani.
“La nostra casa, se ben ricordo, è l’Italia; e all’intera comunità appartiene quel patrimonio artistico che non è soltanto, si rammenti, la più alta testimonianza poetica che l’Occidente abbia dato dopo i giorni della Grecia, ma anche, ormai, la principale ricchezza che ci resti. Ognuno di noi, personalmente, ha il diritto di pretendere che esso non venga diminuito in alcun modo da una pratica sregolata.”