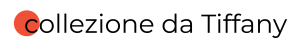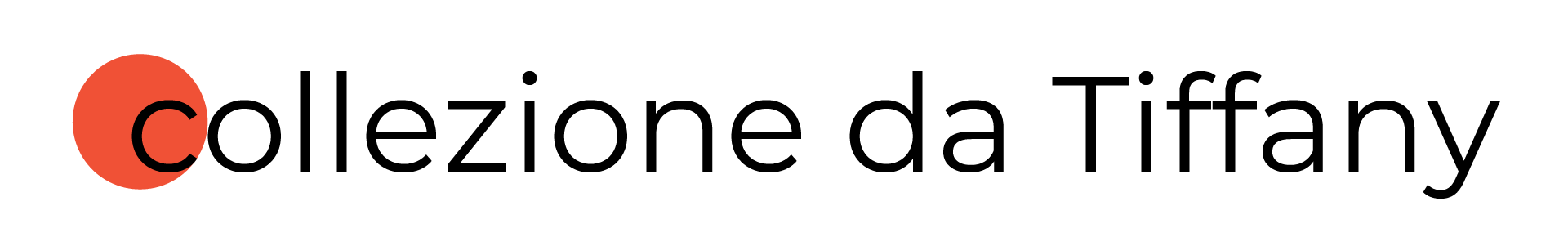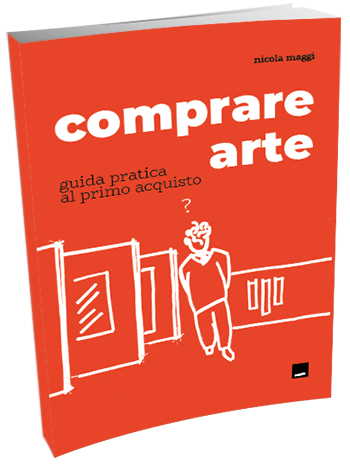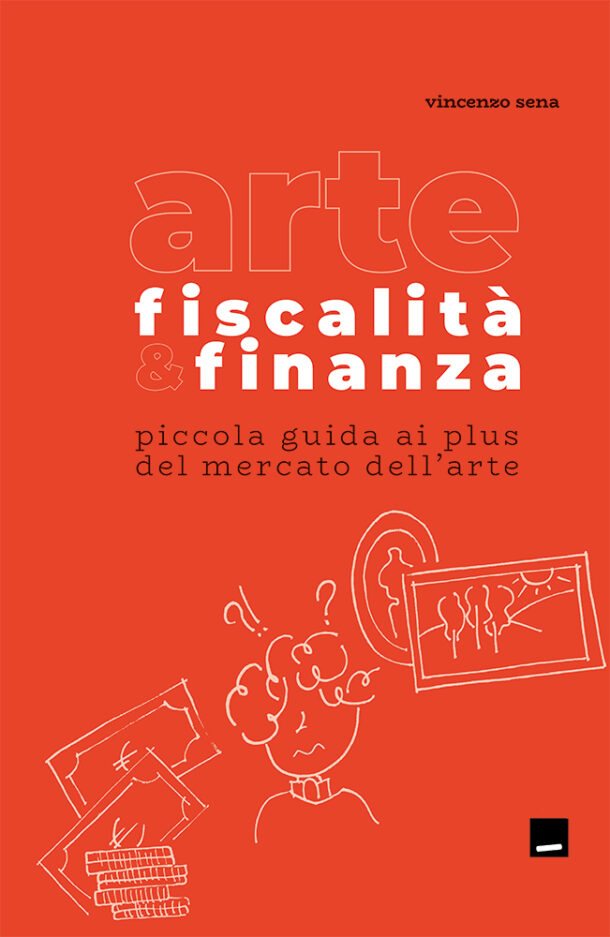Ernest Gombrich è, tra gli storici dell’arte del Novecento, uno dei più celebri e apprezzati. Formatosi nel solco della scuola viennese di Julius Schlosser e Alois Riegl, gli è universalmente riconosciuta una non comune abilità divulgativa, che gli ha permesso di pubblicare testi di storia dell’arte accessibili al pubblico cosiddetto “di massa”. La sua Storia dell’arte, dopo settant’anni, continua a essere pubblicata, venduta e letta da tanti.
Direttore per vent’anni del Warburg Institute di Londra – l’istituto nato per proseguire quella ricerca sul significato nascosto delle arti visive inaugurata da Aby Warburg – grazie al suo spiccato interesse per la percezione individuale e per la psicologia dell’arte, si è spesso dedicato allo studio di tematiche da altri magari considerate tangenziali, come la funzione di luci ed ombre in pittura.
Gombrich ha riflettuto anche sull’evanescenza dell’arte e sul ruolo del restauratore “che deve scegliere fra mali diversi, conosciuti e anche sconosciuti. Suo unico conforto è di non essere solo in questa condizione che accomuna coloro che sono interessati all’evanescente arte del passato. L’attore shakespeariano davanti a un distico rimato che non rima più per i mutamenti della lingua, il musicista davanti a orchestre in cui i clavicembali originali devono armonizzare con violinisti che usano archetti moderni, il traduttore di un libretto o il restauratore di edifici antichi, ognuno di essi deve decidere di volta in volta quale delle trasposizioni necessarie danneggerà meno ciò che egli considera l’unità delle relazioni cercate dall’artista”.
Una tendenza dissipativa dell’arte che coinvolge soprattutto i suoi materiali costitutivi. Si è già parlato dei problemi legati all’inscurimento della vernice ma ancora più problematico può essere il caso di alterazioni cromatiche dei pigmenti. Questo tipo di degrado è connaturato all’essenza chimico-fisica del pigmento stesso e al rapporto con il legante in cui è immerso.
Un problema che sorge, quindi, al momento dell’elaborazione tecnica operata dal pittore, nei confronti del quale, il più delle volte, se non tutte, il restauratore non può nulla fare.
Un pigmento notoriamente problematico in ambito di conservazione è la biacca, cioè il carbonato basico di piombo di cui si è scritto su queste pagine. Il bianco di piombo è estremamente stabile e durevole, in grado di garantire ai pittori una certa sicurezza riguardo alla tenuta nel corso del tempo. Questo è vero, però, per la tecnica ad olio.
Quando il legante utilizzato è diverso, sorgono i problemi. Il caso più comune di degrado della biacca è legato alla tecnica ad affresco, nella quale, infatti, gli sono sempre stati preferiti pigmenti bianchi diversi, come il bianco di sangiovanni o bianchi di calce in genere.
Prendiamo la celebre Crocifissione nel transetto sinistro della Basilica superiore di Assisi, eseguita dal Cimabue. Come è noto, questo straordinario capolavoro di pittura ad affresco compare oggi, visivamente, “in negativo”, con le figure nere stagliate su uno sfondo giallo, connotate con un che di infernale piuttosto che di salvifico. Ad occhio sembrerebbe un’opera espressionista tedesca in stile Brücke, o una di quelle caricature orrorifiche sulla guerra di Otto Dix.
Invece, si tratta di figure eseguite con una tonalità normale che, in un secondo momento, è però cromaticamente virata. Tale degrado è avvenuto perché il Cimabue ha utilizzato la biacca – in maniera piuttosto ardita, a dire il vero, perché a suo tempo era già conosciuto questo limite del pigmento di piombo – per eseguire le parti chiare soprattutto sugli incarnati. Le particolari condizioni dell’affresco in cui, a differenza della pittura ad olio, il pigmento non è avvolto e protetto dal legante ma è a diretto contatto con la calce del muro e quindi sottoposto all’azione di carbonatazione – ovvero di asciugatura – di essa, ha comportato l’ossidazione del piombo e il successivo viraggio del bianco in nero.
Chimicamente, il degrado è avvenuto perché i pigmenti composti di piombo – non solo la biacca ma anche il giallo di Napoli, il minio e altri – si trasformano in biossido di piombo, di colore tendente al bruno, a contatto con acido solfidrico.
Vani furono i tentativi dei restauratori di riconvertire il colore da nero a bianco: i risultati furono talmente pietosi dal farli desistere e rassegnare.
Se, però, la Crocifissione assisiate del Cimabue è irrimediabilmente compromessa nel suo aspetto originario, non lo è la sua potenza espressiva residua.
Come sottolinea lo storico del restauro Alessandro Conti in due righe particolarmente illuminate, “la biacca annerita si inserisce bene, dal punto di vista cromatico, in questa situazione di non buona conservazione e di danni non reversibili; l’affresco si segue forse meglio con queste alterazioni che con qualsiasi tentativo di recupero del cromatismo originale, che lo stato di conservazione renderebbe inevitabilmente molto parziale”.
Una considerazione che, qualcuno, potrebbe forse ritenere fin troppo ottimistica, ma che sicuramente piacerebbe a Gombrich, amante dell’unicità della percezione visiva individuale.